Nel 1990, l’ingegnere e sociologo francese Abraham Moles scriveva, nel suo libro Art et ordinateur, annuncia una trasformazione radicale dei modi di produzione delle arti: le tecnologie informatiche, i computer diventeranno gli artisti del futuro, garantendo per il fabbisogno dell’umanità i prodotti e progetti artistici necessari. Pioniere dell’applicazione dell’intelligenza artificiale (quando ancora questo termine era poco diffuso) all’arte, Moles spiega che questa mutazione non deve farci paura, perché è nell’ordine delle cose: “l’artista non sarà sostituito dalle macchine, come sta succedendo al contabile o all’operaio, perché l’artista è da sempre una macchina che crea forme visive, sonore, significanti, della musica e della letteratura (…) Si può dire che la sua azione non sarà sostituita ma spostata nella sua funzione”. Ipotizzando una vera e propria simbiosi con i programmi generativi, Moles spiega che l’artista avrà un ruolo più culturale che creativo, dovrà assicurare un contesto di diffusione e di comunicazione per le opere prodotte dalle macchine. Oggi diremmo che l’artista deve assumere il ruolo di curatore.
La predizione di Moles, che congiungeva l’utopia cibernetica — protagonista del dibattito a partire dalla fine degli anni Cinquanta — con il potenziale rivoluzionario delle nuove tecnologie informatiche, appare oggi ancora fortemente provocatoria, in aperto contrasto con una concezione dell’opera d’arte ostinatamente intrisa di romanticismo. Eppure, ogni giorno emergono nuovi esperimenti che mostrano come l’intelligenza artificiale stia trasformando non solo le tecniche della produzione creativa — automatizzando procedure e processi — ma penetri progressivamente anche nel mercato e nelle istituzioni. Una vaga inquietudine accompagna le sempre più frequenti notizie di opere realizzate da software di IA e vendute all’asta, generando un alone di dubbio sulle implicazioni non solo estetiche, ma anche etiche, legali o politiche della trasformazione in corso. Nelle accademie e nelle università cresce l’apprensione per l’uso che studenti, artisti e ricercatori possono fare di strumenti generativi sempre più performanti. E se davvero l’arte fosse automatizzabile, delegabile a un prompt indirizzato a un motore di AI, come sosteneva Moles?
Allora ecco dieci libri per documentarsi, dei consigli di lettura per cercare di capire il rapporto tra arte, design e intelligenza artificiale, per ascoltare la testimonianza di artisti che la usano o la criticano. Non tanto per fugare i dubbi e trovare improbabili e instabili certezze, ma per cogliere l’occasione di questa trasformazione epocale per ripensare il ruolo dell’arte nella nostra società tecnologica.
Sofian Audry, Art in the Age of Machine Learning, MIT Press, 2021
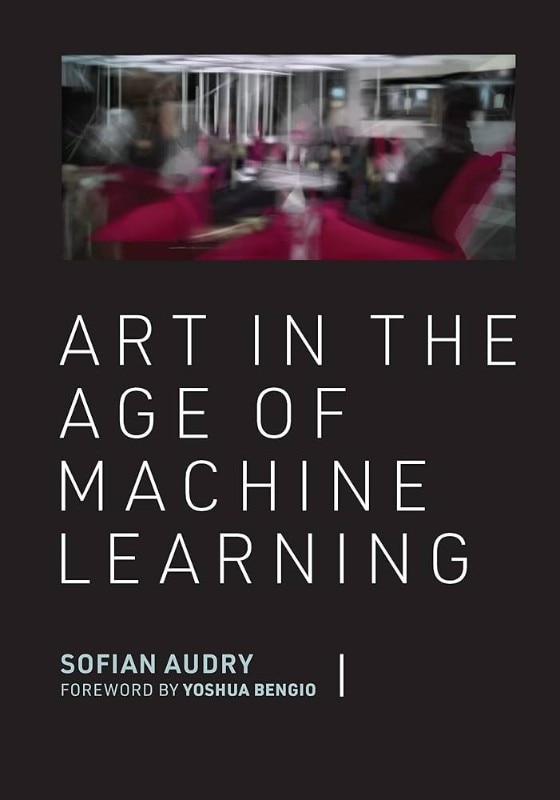
Ormai un classico, Art in the Age of Machine Learning, di Sofian Audry, artista e docente all’UQAM di Montréal, è un libro fondamentale per comprendere le trasformazioni profonde che l’intelligenza artificiale sta introducendo nell’estetica, nella tecnologia e nella cultura. Attraverso un percorso che intreccia pratiche artistiche, strumenti computazionali e riflessioni teoriche, Audry esplora le possibilità offerte da agenti non-umani generativi, evidenziando come il loro comportamento apra nuove frontiere alla sperimentazione e alla critica.
Secondo Audry, viviamo in un’epoca in cui gli algoritmi non operano più secondo logiche formali e regole determinate, ma si comportano piuttosto come entità reticolari, adattive e distribuite, ispirate alla biologia e governate da processi probabilistici. Per affrontare questa nuova condizione, è necessario abbandonare i paradigmi computazionali tradizionali e sviluppare strumenti capaci di cogliere le proprietà emergenti e spesso opache di questi sistemi.
È qui che l’arte entra in gioco: lontana dal finalismo soluzionista della ricerca scientifica, la sperimentazione artistica si rivela uno strumento cruciale per esaminare le implicazioni estetiche (ma non solo) delle tecnologie cosiddette “intelligenti”. L’approccio processuale degli artisti, spiega Audry, consente di esplorare ciò che nei sistemi sfugge alla verifica e all’efficienza, aprendo uno spazio critico ed “eretico” che è oggi più che mai necessario. Un saggio lucido, che offre una mappa preziosa per orientarsi nel paesaggio, sempre più sfumato, tra umano e artificiale.
Fred Ritchin, The Synthetic Eye, Photography Transformed in the Age of AI, Thames & Hudson, 2025

Con The Synthetic Eye, Fred Ritchin — teorico tra i più lucidi del rapporto tra fotografia e tecnologia — ci offre una riflessione urgente e chiarificatrice sul destino dell’immagine fotografica nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Il libro esplora come l’avvento della sintesi algoritmica stia rivoluzionando non solo il modo in cui le immagini sono prodotte, ma anche la loro funzione culturale, sociale e politica.
Dopo la rivoluzione del digitale, Ritchin individua nell’AI una nuova soglia critica: un punto di svolta che mette in discussione la fotografia come testimonianza, come documento, come “sguardo sul reale”. Ma The Synthetic Eye non vuole essere un lamento nostalgico, ma una mappa orientata all’esplorazione delle nuove possibilità offerte dall’AI: l’autore invita fotografi e artisti visivi a reinventare radicalmente il medium, così come i pittori fecero dopo l’invenzione della fotografia nell’Ottocento.
Includendo un ricchissimo portfolio di immagini generate tramite DALL-E, DreamStudio e altri strumenti, l’autore introduce un’importante proposta teorica, l’idea dei Four Corners: ogni immagine online dovrebbe offrire accesso al contesto di produzione, all’autore, alle fonti e a immagini correlate — per restituire trasparenza e responsabilità alla cultura visiva digitale.
Hito Steyerl, Medium Hot. Images in the Age of Heat, Verso, 2025

Aspettavamo con impazienza il nuovo libro di Hito Steyerl, artista e teorica tra le più influenti della scena contemporanea. Uscito da meno di un mese da Verso, Medium Hot, è una raccolta di saggi che si interroga con lucidità e urgenza sulla produzione di immagini nell’epoca dell’intelligenza artificiale e del cambiamento climatico. Sostenuto dal consueto stile incisivo e da un pensiero esigente, il libro affronta i limiti e le contraddizioni dell’attuale ecosistema visivo: la generazione algoritmica delle immagini, l’uso dei modelli linguistici di larga scala, la “fabbrica” delle immagini digitali, i fondamenti e le conseguenze materiali. Steyerl mette in discussione non solo come le immagini vengono prodotte, ma anche per chi e a quale costo: può esistere un’arte generata non solo dalle macchine, ma anche per le macchine?
In un commento, l’artista Trevor Paglen descrive il libro come “un viaggio dantesco attraverso l’inferno ruggente della cultura visiva del XXI secolo”: un’immersione ricca di luci e ombre nelle profondità incandescenti di un paesaggio iconografico in piena trasformazione. E allo stesso tempo, una presa di posizione critica radicale che rivela come le immagini non sono mai innocue, e in cui l’intersezione tra arte, lavoro, ecologia e tecnologie emergenti ridefinisce in profondità ciò che chiamiamo arte. Imprescindibile.
Agnieszka Kurant, Collective Intelligence, Sternberg Press, 2025
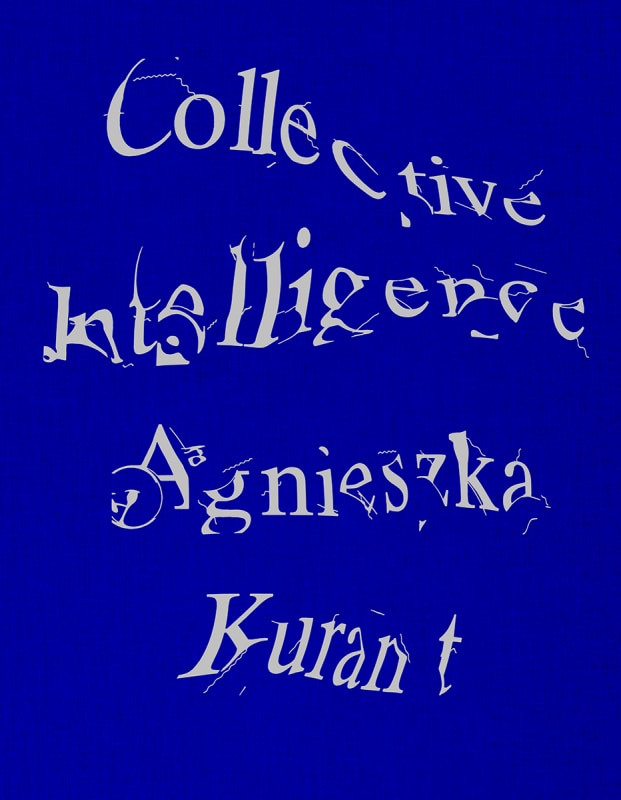
Corposo e riccamente illustrato, il volume offre una visione d’insieme della pratica di Agnieszka Kurant, artista concettuale polacca che negli ultimi dieci anni ha sviluppato un percorso singolare e profondamente interdisciplinare. Il titolo — Collective Intelligence — richiama i concetti pionieristici formulati negli anni ’90 da Pierre Lévy (intelligenza collettiva) e Derrick de Kerckhove (intelligenza connettiva), in piena rivoluzione digitale. Ma per Kurant, l’intelligenza collettiva non è soltanto una rete tra soggetti umani: è un campo espanso che include intelligenze non umane — microbiche, artificiali, animali — esplorandone le forme di creatività emergente e i meccanismi di sfruttamento all’interno del capitalismo di sorveglianza.
Curato da Stefanie Hessler, Jenny Jaskey e dall’artista stessa, il libro si presenta come un atlante articolato in cui testi teorici e documentazione visiva convivono in un denso caleidoscopio di idee e immagini. La sezione Phenomena, dal taglio quasi enciclopedico, attraversa l’intero volume e accompagna la lettura come dispositivo concettuale, collocando l’intelligenza artificiale nel più ampio orizzonte dell’intelligenza collettiva — osservabile allo stesso modo nei slime molds, nelle colonie di termiti, nei movimenti sociali, nelle città, su Internet e all’interno del nostro cervello.
I contributi di ricercatori e filosofi come Rosi Braidotti, Graham Harman, Jussi Parikka e Franco “Bifo” Berardi arricchiscono il volume con prospettive trasversali, confermando la solidità teorica di un’opera che interroga in profondità le condizioni contemporanee della produzione di senso, valore e conoscenza. Più che una monografia, un laboratorio.
Trevor Paglen, Adversarially Evolved Hallucinations, a cura di Anthony Downey, Sternberg Press, 2024
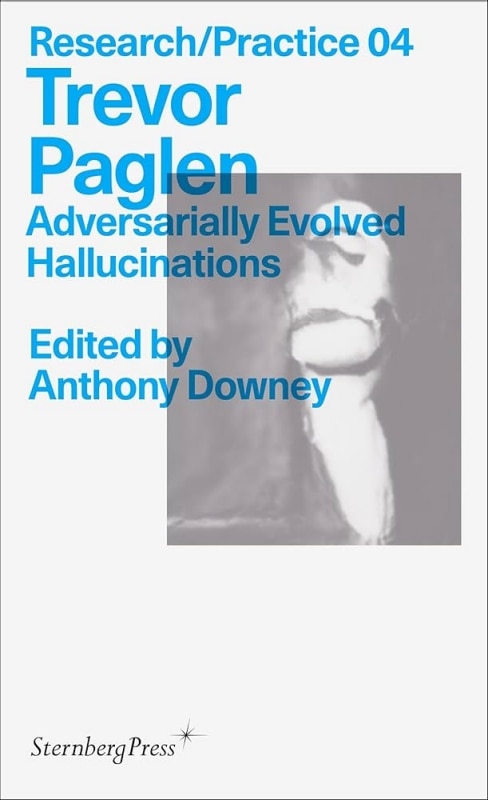
A cura di Anthony Downey, questo volume rappresenta un accesso prezioso al cantiere concettuale e operativo di Trevor Paglen, tra gli artisti più radicali nel mettere in discussione i fondamenti dell’intelligenza artificiale. Conosciuto per le sue installazioni che indagano la sorveglianza di massa, la raccolta dei dati e i meccanismi di occultamento del potere, l’artista americano affronta l’AI non solo come strumento, ma come dispositivo capace di ristrutturare in profondità la nostra percezione del mondo. Ricco di un’iconografia vertiginosa, il libro mette in luce come la visione automatizzata, tutt’altro che neutra, sia soggetta a derive allucinatorie: le immagini prodotte dall’AI sembrano restituire il reale, ma rivelano invece le profonde distorsioni insite nei suoi processi di classificazione.
In particolare, la serie Adversarially Evolved Hallucinations dà forma a una sorta di automatismo visionario, una nuova arte surrealista della macchina, in cui gli errori di lettura e gli scarti percettivi diventano materia estetica e critica. Attraverso una forma di “ingegneria inversa”, Paglen propone un’indagine che parte dagli esiti visivi per risalire alle logiche opache che li generano, interrogando le condizioni stesse della visione e della conoscenza nel contesto automatizzato contemporaneo. Un libro necessario per comprendere come le tecnologie dell’AI non si limitino a osservare il mondo, ma contribuiscano a determinarne attivamente i contorni (sempre più allucinati e allucinanti).
Kate Crawford, Né intelligente né artificiale. Il lato oscuro dell'IA, il Mulino, 2021
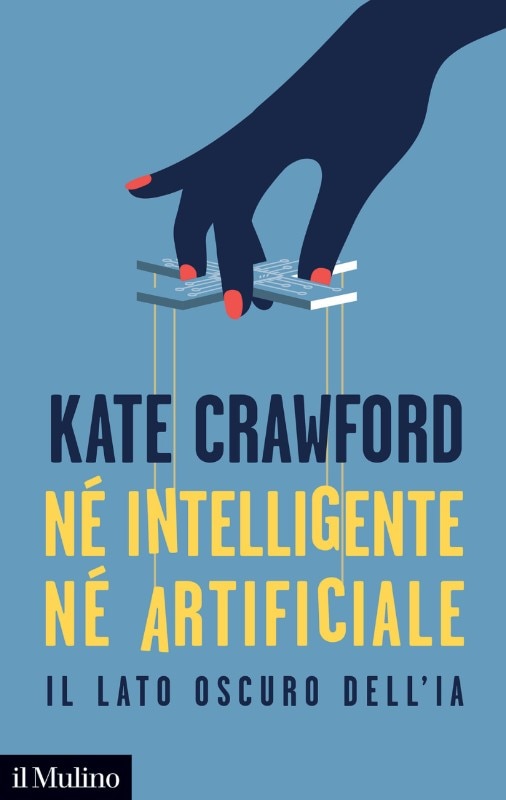
Kate Crawford si è imposta negli ultimi anni come una figura di riferimento nel dibattito critico sull’intelligenza artificiale. I suoi vasti diagrammi, a metà tra arte e investigazione critica — realizzati in collaborazione con Vladan Joler (tra cui Anatomy of an AI System e Calculating Empires: A Genealogy of Technology and Power Since 1500, con cui ha recentemente vinto il Leone d’Argento alla Biennale di Venezia) — traducono in forme visive complesse le intersezioni tra tecnologia, estetica e potere.
Il libro Atlas of AI si muove nella stessa direzione, proponendosi come un’inchiesta senza concessioni sulle pieghe nascoste dell’industria dell’intelligenza artificiale: dalle miniere di litio e cobalto ai magazzini dei data center, dal lavoro invisibile dei click workers ai dataset utilizzati per addestrare le reti neurali, Atlas of AI restituisce un’immagine inquietante ma necessaria dell’ecosistema che rende possibile l’illusione dell’automazione. Ne emerge un ritratto dell’AI come strumento di centralizzazione del potere, al servizio di una nuova forma di governance post-democratica. Un libro fiammeggiante, che si legge come un romanzo e fa pensare come un saggio di filosofia.
Valentina Tanni, Conversazioni con la macchina. Il dialogo dell’arte con le intelligenze artificiali, Tlon, 2025

In un momento in cui il dibattito sull’intelligenza artificiale tende a irrigidirsi in posizioni polarizzate, questo piccolo libro offre un contributo prezioso per la sua capacità di riportare l’attenzione su una prospettiva storica e relazionale spesso trascurata. Rievocando l’approccio sperimentale degli anni Cinquanta e Sessanta, quando la macchina era concepita come interlocutrice e non come avversaria, la storica dell’arte Valentina Tanni, già autrice di una folgorante Memestetica (Nero, 2020) propone, con il suo solito brio, un repertorio di metafore che invitano a ripensare il rapporto tra esseri umani e tecnologie intelligenti.
Invece di cedere al determinismo tecnologico, il saggio esplora le possibilità offerte dall’arte come spazio critico in cui mettere alla prova forme di coabitazione sensibile con le macchine, opponendosi all’idea di un’intelligenza artificiale opaca e onnipotente. Un testo misurato ma incisivo, che invita a recuperare un atteggiamento di dialogo, senza rinunciare alla vigilanza.
Matteo Pasquinelli, Nell’occhio dell’algoritmo. Storia e critica dell'intelligenza artificiale, Carocci, 2025
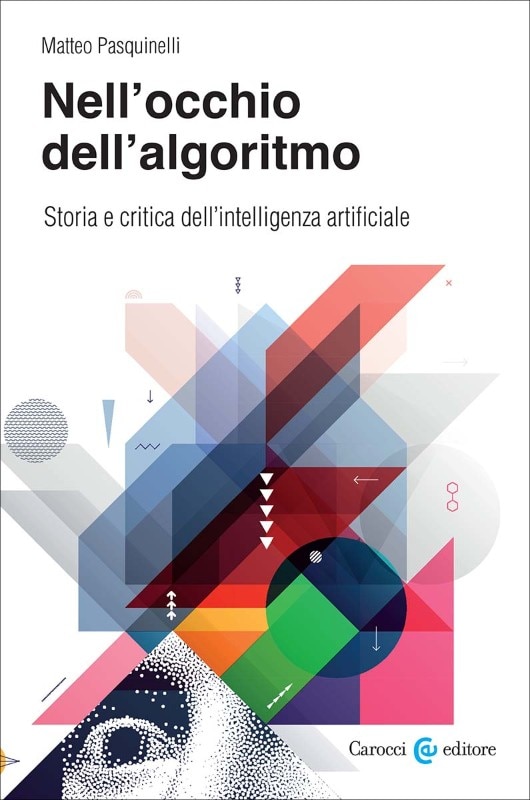
In The Eye of the Master, il filosofo delle scienze Matteo Pasquinelli (Ca’ Foscari, Venezia) propone una brillante contro-narrazione della storia dell’intelligenza artificiale. In controtendenza con l’idea che l’IA nasca come emulazione della mente o del cervello, Pasquinelli ne rintraccia le radici nei processi storici di razionalizzazione del lavoro, dalla meccanica industriale di Babbage fino alla logistica algoritmica contemporanea. Tradotto in diverse lingue (è appena uscita l’edizione italiana, Nell’occhio dell’algoritmo. Storia e critica dell'intelligenza artificiale, Carocci, 2025), denso e mosso da un’esigente prospettiva critica, il libro smonta l’idea che l’IA possa divenire autonoma o senziente: ciò che essa automatizza non è l’intelligenza in sé, ma le relazioni sociali e produttive.
Il libro ricostruisce il legame profondo tra matematica, statistiche cognitive e ingegneria del comando, mostrando come concetti apparentemente neutri — come il QI o il mitico Perceptron — abbiano contribuito a naturalizzare gerarchie e discriminazioni. Pasquinelli ci invita a una nuova alfabetizzazione politica dell’IA, denunciandone le derive ideologiche e sottolineando come, nell’economia delle piattaforme, non siano i lavoratori a essere sostituiti dai robot, bensì i manager dalle macchine. Un saggio essenziale per chi voglia comprendere l’automazione non come fantascienza, ma come dispositivo di potere.
Anthony Masure, Artificial Design: Creation Versus Machine Learning, HEAD – Publishing, coll. “Manifestes,” 2023
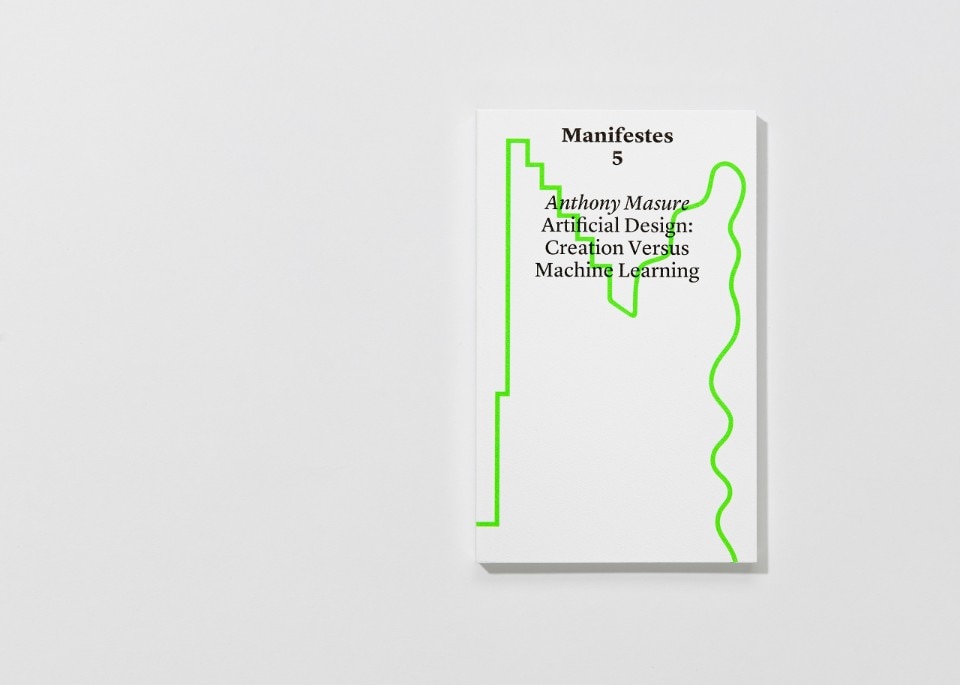
Tutti parlano di come l’intelligenza artificiale stia dando forma a una nuova rivoluzione nel design, ma sono ancora pochi i testi che descrivono con precisione questa mutazione in atto. Il saggio di Anthony Masure — teorico del design e specialista di blockchain — breve ma incisivo come un manifesto, risulta in questo senso particolarmente illuminante. Disponibile sia in formato cartaceo sia in libero accesso online, il testo non alimenta né scenari distopici né utopie tecnofile: affronta invece con rigore critico le implicazioni concrete — attuali e potenziali — del machine learning per il design, inteso non solo come insieme di pratiche, ma come forma di pensiero situato, culturale e politico.
Invece di insistere sulla spettacolarità dei risultati prodotti dai modelli generativi, il libro mostra come queste tecnologie, spesso basate su dataset opachi e standardizzati, tendano a riprodurre strutture visive esistenti più che a generare reali alternative. In questo modo, sposta l’attenzione: non tanto su ciò che queste macchine producono, quanto su come trasformano i parametri stessi del progetto, la nozione di creatività e i regimi di visibilità.
Cinque sono le piste complementari che il libro esplora, dando forma a una riflessione critica e operativa sulle potenzialità creative del machine learning nel design: rivelare le dinamiche di standardizzazione; responsabilizzare le forme di semplificazione imposte dal sistema; giocare con i limiti della predizione; tradurre codici culturali; e inventare nuovi modi di collaborare. Si tratta, in definitiva, di passare dall’intelligenza artificiale a un’intelligenza dell’artificiale, che — come scrive Masure — “consiste nell’abbandonare la simulazione servile e schematica della psicologia umana per fare spazio all’alterità e alle asperità delle macchine.”
The World Through AI Exploring Latent Spaces, a cura di Antonio Somaini, JBE, 2025.
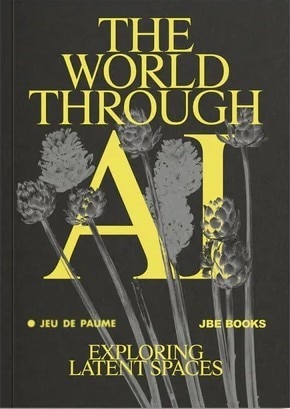
Pensato in occasione dell’omonima mostra al Jeu de Paume di Parigi, The World Through AI non è un semplice catalogo, ma si presenta come un libro-manifesto, come una cartografia critica dell’immaginario emergente generato dalle intelligenze artificiali. È negli “spazi latenti” – come li definisce il curatore Antonio Somaini – che si schiude una nuova dimensione del sentire e del conoscere: profondità matematiche invisibili, dove le macchine apprendono da sé a generare immagini e suoni, a tradurre, a parlare, a scrivere. Ma soprattutto, a vedere. E a costruire mondi. Il libro mette a fuoco proprio questo scarto vertiginoso, mostrando come l’AI non sia soltanto uno strumento, ma un nuovo interlocutore della sensibilità, capace di riformulare radicalmente i processi della creazione.
Attraverso l’analisi di opere di figure chiave della scena artistica contemporanea, da Kate Crawford & Vladan Joler a Hito Steyerl, da Trevor Paglen a Agnieszka Kurant, da Fabien Giraud a Christian Marclay, il libro compone un atlante visivo e concettuale che ci invita a ripensare la relazione tra umani e macchine, immaginazione e calcolo, visione e opacità.
Un libro necessario, per comprendere non solo come le macchine vedono il mondo, ma come, attraverso di esse, anche noi siamo chiamati a rivedere il nostro sguardo.


