Quello di luglio-agosto è un numero doppio, dedicato a plastica e tessuto. Da un lato c’è la plastica, l’enfant terrible dell’architettura. Il materiale del XX secolo, delle visioni di un avvenire dalla mobilità più leggera dell’aria e dei gonfiabili di Biosphere 2 (1989), archetipo di ambiente abitabile interplanetario. Ma anche il simbolo di una cultura individualista dello spreco, di un ecosistema soffocato dalle bottiglie di plastica e strangolato dalle microplastiche.
D’altra parte il tessuto, controparte dell’architettura, è invece sostegno e spalla, come Lilly Reich per Mies van der Rohe. Come nelle tensostrutture di Frei Otto per le Olimpiadi di Monaco del 1972 o nell’Hajj Terminal dell’aeroporto di Gedda di SOM del 1981. L’effimero della tenda, elevato alla scala monumentale dell’infrastruttura pubblica. “Una sola parola: plastiche”: è il consiglio che il signor McGuire dava a Dustin Hoffman ne Il laureato (1967). “Le plastiche hanno un grande futuro. Pensaci”. Aveva ragione: hanno invaso il mondo con innumerevoli innovazioni. Sigillature a prova d’aria e giunti a prova d’acqua: membrane, barriere al vapore, gonfiabili. I tetti piani e gli edifici di vetro con l’ aria condizionata sono nati dalla libertà strutturale del calcestruzzo, ma non sarebbero stati possibili senza le membrane plastiche.
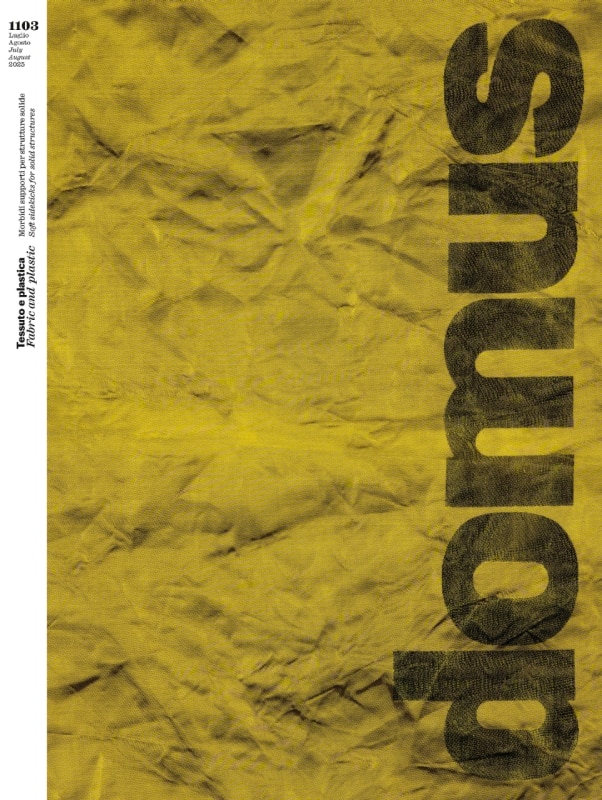
La plastica è stata anche il precursore di numerosi declassamenti materiali sotto forma di finiture false, impiallacciature, pannelli Dibond o laminati. Al di là della sfera degli strumenti al servizio dell’architettura, bottiglie, penne a sfera e giocattoli per l’infanzia sono divenuti il contenuto principale delle discariche e hanno infine popolato le spiagge, il mare e lo stomaco degli albatros. Nata dagli idrocarburi, la plastica ha perso presto la sua aura di modernità per iventare il materiale più odiato del settore. Spesso per buone ragioni. Tuttavia, lo spreco non è intrinsecamente legato al materiale, ma alla sua cattiva applicazione. Nell’ambiente non si trovano né mattoncini Lego, né tappi e cannucce. E di Lego non se ne trovano nemmeno in discarica, perché sono progettati per non invecchiare mai: quelli della mia infanzia sono perfettamente compatibili con quelli di mio figlio. Un genere di sostenibilità estetica che tutela significato e compatibilità future.
La maggior parte dell’ambiente costruito del futuro è già qui. Il problema degli architetti sarà reimmaginare il modo di abitare l’esistente.
Quando studiavo a Barcellona, la passione per il graphic novel mi avvicinò agli Archigram e alla loro “ricerca di un nuovo vernacolare, qualcosa che stia accanto alle capsule spaziali, ai computer e alle confezioni usa-e-getta dell’era atomico-elettronica”. Il designer danese Verner Panton, con le cui lampade ero cresciuto, tradusse in realtà queste narrazioni con i suoi interni colorati, come il Fantasy Landscape di Visiona II o le aree comuni di Der Spiegel (1969). Mondi che celebravano tonalità cromatiche, saturazione e luminosità ottenibili con le plastiche e i tessuti.
Quando mi trasferii in Olanda, scoprii Joep van Lieshout, che con la fibra di vetro crea visioni survivaliste di una repubblica dalla cultura alternativa. Angoli arrotondati e colore continuo davano un aspetto amichevole ai falsi carri armati e ai kalashnikov.

I generatori eolici, che contribuiscono a rendere la Danimarca energeticamente autosufficiente e permettono di esportare energia, sono formati da una pultrusione di plastiche super forte fatta con tessuti imbevuti di resina. Il diametro di 236 metri delle eliche fa di loro le costruzioni più alte della Danimarca: immaginate un mondo in cui un artefatto di fibre intessute e impregnate di resina si innalzi su tutto il resto, comprese le cime delle colline e le torri. Nell’estate del 1995 andai a Monaco di Baviera e restai sbalordito dagli involucri informali del baldacchino olimpico di Frei Otto. La doppia curva anticlastica rappresentava un vocabolario formale radicalmente nuovo: al tempo stesso razionale ed espressiva, strutturale quanto scultorea. La morbidezza della plastica offriva una sorta di mondo alternativo, fatto di forme non imposte, ma emanate dalla tattilità tessile del materiale.
Nel 1998 iniziai a lavorare con Rem Koolhaas e tutto lo studio andò a Bordeaux per l’inaugurazione della Maison che prende il nome dalla città. Le geometrie euclidee del monolito di calcestruzzo sospeso e la lacuna inserita tra l’oggetto e il terreno erano animate da sete pesanti, cotoni lievi, juta e vernici. I sipari disegnati da Petra Blaisse erano un elemento integrato e irreplicabile dell’architettura. Erano l’ingrediente che rendeva possibile – anzi, desiderabile – vivere in un padiglione di vetro.
L’anno seguente, lavorai con Petra al progetto della Biblioteca pubblica di Seattle, impegnati in acrobazie che sfidavano la gravità richieste dalla realizzazione di elementi galleggianti. Disegnavamo moquette colorate con ingrandimenti fotografici di erba e foglie per creare un’esperienza quasi domestica negli ampi spazi pubblici della living room e della reading room.

Nel nostro lavoro abbiamo sperimentato la capacità dei gonfiabili di essere di grande impatto con mezzi minimi. L’epidermide metallica riflettente dell’Orb al Burning Man del 2018 è partita come miraggio immateriale, ma la tensione elettrostatica delle sue superfici tendeva ad attirare particelle di polvere. Il risultato era una percezione di permanenza, una pesante materialità da corpo planetario. E per il padiglione della Serpentine del 2016, la rapidità e la necessità di smontare e rimontare ci hanno fatto optare per una specie di scatola di Lego di fibra di vetro: 1.802 identiche pultrusioni formano una parete che svela un interno simile a una caverna, chiusa come un canyon o aperta a griglia, massa informe o contenitore a seconda dell’angolazione.
Alejandro Zaera-Polo apre questo numero con una panoramica sociale della politica della plastica. Petra Blaisse racconta le sue sperimentazioni con i materiali tessili, mentre Nick Tidball illustra come la moda possa servire alla prototipazione dell’innovazione materiale. Siamo andati a trovare due pionieri della sperimentazione, José Selgas e Lucía Cano, per conoscere il loro viaggio nel repertorio dei materiali industriali. MAD torna con due progetti opposti: uno stadio e un’installazione. Allmannwappner + Menges Scheffler Architekten + Jan Knippers Ingenieure lavorano con il tessuto di fibra di vetro in forma di ragnatela arabescata mentre MVRDV stende fibre di plastica riciclata in un gigantesco tappeto pubblico a Bangkok. Guillermo Santomà e TEST uniscono in un interno la tettonica del tessile e la solidità del cemento, mentre Erased Studio usa un’unica tela per la metamorfica scenografia di un matrimonio.

Wolfgang Volz ci accompagna nell’odissea dei tessuti monumentali alla scala urbana e del paesaggio di Christo e Jeanne-Claude. Il divano Sausage di Willo Perron è l’equivalente di una sciarpa che si può avvolgere in forme impreviste. Charlotte Kingsnorth e Finemateria analizzano invece i capi opposti dello spettro, dal biologico all’euclideo. La collezione Hubs di Do Ho Su è un modello BIM solidificato nel tessuto, mentre Andrés Reisinger conquista Gedda con drappi dai colori caldi. Infine, Christoph Niemann riflette sulla potente semplicità dell’ordinario mattoncino Lego.
Questo numero esplora l’importanza che le membrane flessibili e le morbide trame di plastica e tessuti ancora conservano. La maggior parte dell’ambiente costruito del futuro è già qui. Il problema degli architetti sarà reimmaginare il modo di abitare l’esistente. Interventi leggeri sull’ossatura di edifici che hanno perso importanza, stratificazioni effimere. La condizione vitale di strutture abbandonate può essere rinnovata dalla leggerezza e dal riuso, dalla versatilità e dalla mobilità di plastiche e tessuti.
Immagine di apertura: Photo Anna Jastrzebska/Alamy Stock Photo


