Le ragioni di un incontro
A Italo Lupi. Da quando Stefano Boeri è direttore di Domus, incontrandoci in varie circostanze ci siamo ripromessi di fare qualcosa insieme. Ci è parso che proprio il tema del Salone del Mobile fosse l’occasione buona per riunire le due redazioni, non in una tavola rotonda, perché non si tratta di questo, ma in una specie di riunione congiunta, come fossimo ognuno nella propria sede a fare discorsi non strettamente legati al design, ma aperti a territori differenti. Credo che questo incontro sia un’occasione unica, una bella dimostrazione di anticonformismo e di apertura culturale.
d Stefano Boeri. Anche per noi è stato un immenso piacere organizzare questo incontro inedito che, al di là del tema che affronteremo oggi, mi auguro possa diventare una consuetudine. L’incontro tra due redazioni milanesi, legate a editori concorrenti ma accomunate dalle stesse libere curiosità e ossessioni, potrebbe generare momenti di grande interesse e tensione. Ma c’è di più: il fatto che due luoghi di produzione intellettuale come Abitare e Domus si parlino, si incontrino, è anche un segnale importante e controcorrente in una città come Milano che è invece fatta di isole d’eccellenza separate una dall’altra, di luoghi di ricerca, magari nello stesso campo, che non si parlano. È un bellissimo segno.
I numeri di aprile
d Stefano Boeri. Nel numero di Domus di aprile abbiamo deciso di provare a guardare la sfera della progettazione degli oggetti complessi da tre prospettive principali. La prima ha a che vedere con la propensione comunicativa del design, con la sua capacità di aggiungere valore simbolico e identitario – grazie anche alla firma del designer – ai prodotti e al brand delle aziende. La seconda si misura invece con una sfera ancora strettamente legata alla produzione, all’affinamento funzionale ed estetico di oggetti d’uso prodotti in grandi serie. La terza infine è una prospettiva che vede il design come una forma di sopravvivenza, di progettazione di prodotti e oggetti d’uso nati dall’autorganizzazione di comunità di utenti-progettisti.
A Italo Lupi. Ho guardato questo numero di Domus con ammirazione. È un numero molto differente dai vostri soliti perché mi pare proponga un taglio assolutamente inedito, con un’organizzazione molto chiara. Noi abbiamo fatto invece un numero che non si discosta dai nostri abituali. Non è dedicato al Salone in modo specifico, ma ha pagine di design che indicano alcune preferenze. Abitare dà giudizi forti, nel senso che seleziona alcune cose e le presenta dando implicitamente un giudizio di positività. Nel numero c’è poi la ripresa di uno dei temi cari alla rivista, quello del ricordo, della rivisitazione di personaggi – in questo caso Roberto Poggi – che sono stati influenti in campi differenti, sia nel design che nell’architettura. Siamo tra i pochi che ancora ricordano non solo i maestri, ma anche gli artigiani di questo mestiere.
d Joseph Grima. Abbiamo deciso in questo numero di guardare alle spalle dell’oggetto, capire com’è arrivato là dove si trova. Anche per questo, i vari capitoli cominciano con le coordinate “Google Earth”, scelta che ci relaziona tra l’altro ai nuovi metodi di guardare lo spazio a distanza. Il sottotitolo di Domus è “Architettura, design, arte e informazione”: per questo numero abbiamo compiuto un lavoro d’indagine sulle complesse relazioni fra l’identità degli oggetti nell’ambito ‘comunicativo’ del design e gli aspetti geografici della loro produzione.
d Francesco Librizzi. Osservare il design dall’interno produce una specie di effetto serra, un surriscaldamento di questi “iceberg” che si stanno sciogliendo e che si manifestano come assenza di innovazione, di prodotti veramente nuovi. Con il numero di aprile, Domus ha cercato, sull’onda del pensiero di Paul Virilio, di allargare l’attenzione dallo spazio in cui i prodotti del design vengono fabbricati e consumati anche al tempo in cui vengono simultaneamente condivisi. Parlando non solo di oggetti, ma degli eventi che li hanno determinati, di come alcuni processi agiscano contemporaneamente sul reale. Credo si tratti di un buon punto di osservazione per una rivista che si rivolge sostanzialmente a degli autori del design: parlare di nuove strategie, di strumenti, piuttosto che continuare ad ampliare il repertorio delle immagini.
Comunicare il design
d Mario Piazza. Di numero in numero ci siamo posti il problema di come presentare il design su Domus. Il numero di aprile è volutamente, fortemente sistematico e pone una questione generale: con quali strumenti conoscitivi possiamo indagare oggi il design, o meglio i fenomeni del geodesign. È evidente che approcci critici strettamente disciplinari sono sempre più insufficienti. Servono quindi nuovi stimoli interpretativi che a nostro avviso possono essere sviluppati incrociando dispositivi multidisciplinari (estetica, sociologia, economia, ecc.) e restituzioni multimodali. Non si può più leggere il design se non si fanno sforzi per innestare e usare discipline diverse, ma bisogna anche essere in grado di formalizzare queste letture e investigazioni con modelli narrativi plurimi, anzi bisogna ‘navigare’ nelle diverse forme mediatiche. Questo approccio è sempre più necessario, perché il modello autoriale, nel geodesign, è un fenomeno marginale. Le opere (gli oggetti con un nome) spariranno o sempre di più si mescoleranno (ibridi fluidi), e forse con loro anche gli autori. Dietro questo abbozzato scenario c’è il tema più grande di come si faranno a capire i problemi del design, i suoi linguaggi, le sue specificità. Nel numero di aprile le tre categorie sono servite a organizzare “un catalogo possibile” del fenomeno design, con una certa e insolita libertà nella selezione, quasi una campionatura random, che ha supportato le argomentazioni delle nostre ipotesi, ma che necessariamente non si è potuta declinare con una maggiore finezza. Dietro al “design per comunicare, produrre e sopravvivere” si celano possibilità di lettura dei modi organizzativi del progetto, delle forme con cui si sviluppano le innovazioni e la sperimentazione, delle modalità con cui si incrociano gli strumenti compositivi e linguistici, delle strategie con cui si traduce l’espressività. E tutto ciò avviene attraverso flussi, scambi, interazioni che rendono fluidi e mobili gli insiemi da noi usati. Per capirci, il “design per la sopravvivenza” non è solo una categoria del senso morale ed etico di svolgere il progetto, ma anche la rappresentazione del linguaggio che la esprime. Allora la possiamo ritrovare in altri insiemi (anche lontani) come quello dove stanno le aziende ‘mature’ del design. Penso a Vitra che proprio dell’estetica terzomondista del bricoleur sta usando forme, stilemi, espressività. In realtà, il nostro sforzo, e forse quello delle riviste, dovrebbe essere di pungolo verso un dibattito sugli strumenti conoscitivi, prima che sulla forma degli oggetti. La salvaguardia del territorio-design, dell’oggetto, del luogo d’uso è uno dei baluardi entro cui si è sempre mossa Abitare. La nostra rivista cerca di accennare modalità differenti di lettura, cerca le pieghe, gli altri volti e lo fa con un approccio registico, interpolando differenti forme di narrazione e di scrittura. È una sfida per il futuro.
d Loredana Mascheroni. Mi sembra emblematica la scelta di parlare degli oggetti affrontando le tematiche che stanno loro attorno. Il numero che abbiamo presentato l’anno scorso in occasione del Salone aveva in copertina la molto discussa lampada di Philippe Starck a forma di mitra. Ci chiedemmo, allora, se sposavamo in qualche modo quell’oggetto, che cosa volevamo sostenere con quell’operazione. La risposta fu: vogliamo parlare della moralità del design. Abbiamo fatto un’operazione molto rischiosa, che sicuramente ha attirato molte polemiche da parte degli operatori dell’informazione e anche dei produttori. Questo atteggiamento, che può essere magari considerato presuntuoso, mi sembra esemplifichi il nostro modo molto peculiare di parlare del design e del suo mondo, la nostra volontà di stimolare il dibattito, di sensibilizzare e quindi di generare dei cambiamenti.
d Marco Belpoliti. Sarebbe interessante cercare di fare uscire le vostre riviste dal loro mestiere. Per chi si scrive? Per quale lettore? Per i colleghi, quelli vivi e quelli morti? Per gli studiosi? Questo è un aspetto etico molto importante. Spessissimo le riviste di architettura e di design sono in gergo. Ho fotocopiato a volte degli articoli e li ho fatti leggere ai miei studenti. È interessante la risposta. Spesso sono assolutamente incomprensibili, ma non nei termini, proprio nella prosa, nel ritmo, nella costruzione sintattica delle frasi. A volte sembra che non abbiano dei soggetti grammaticali evidenti; non perché siano scorrette, ma perché il soggetto sembra celato, assente. Scritte in architettese.
Design, quotidianità ed eccezionalità
A Marco Romanelli. Stefano Boeri ha detto: propensione comunicativa, produzione e forma di sopravvivenza. Ecco, devo dire che Io ho una concezione del design molto vicina alla quotidianità, più che all’eccezionalità. Mi tornano in mente le parole di Giulio Carlo Argan quando sosteneva che il design sarebbe divenuto “l’arte popolare del nuovo millennio”. Purtroppo la situazione attuale porta a dire che Argan ha sbagliato, lasciandoci tuttavia uno straordinario messaggio di speranza. Su quest’onda credo che il design dovrebbe essere qualcosa che aiuti la vita di ciascuno, che la rende più facile, più felice, più giusta. Preferisco pensare a un design ‘corretto’ che non a un design ‘straordinario’. In questo senso la visita al Salone non mi ha dato delle conferme. Se pensiamo a un design quotidiano dobbiamo pensare a degli oggetti e in realtà, statisticamente, all’ultimo Salone del Mobile l’elenco degli oggetti felicemente conclusi nel loro iter progettuale era assai più breve che negli anni passati. Che cosa ha preso il posto di questo “design come oggetto”? Un “design come sistema comunicativo”.
A Fulvio Irace. Tornando alla parola “eccezionalità”, bisogna forse fare alcune distinzioni. C’è un’eccezionalità che etimologicamente è qualche cosa che eccede la norma, e c’è un’eccezionalità intesa in senso mediatico, che forse è quella a cui si riferiva Marco Romanelli. L’eccezionalità come deroga rispetto alla norma è una nozione intrinseca alla storia del design. Il modernismo è ricco di oggetti eccezionali da questo punto di vista (che cosa c’è di più eccezionale della Maison de Verre di Pierre Chareau, un oggetto che è assolutamente al di fuori di ogni schema?). La cultura del modernismo si è posta la questione se l’eccezionalità dell’oggetto sia prova di scarsa moralità, di scarsa sensibilità ai temi della democrazia ambientale, o se invece si possa cogliere in essa una positività relativa alla sperimentazione del prototipo. Per fare un esempio attuale, le sedute di Ron Arad esposte al Metropol mi sono sembrate un progetto molto interessante, anche se certo non possono soddisfare i criteri di democrazia di cui si diceva prima. Ma credo che sarebbe moralismo, quindi non vera moralità, negare la liceità di compiere un’operazione stravagante eppure, a mio avviso, ricca di contenuti intrinseci alla moralità del progettista che deve sperimentare delle novità e una propria forma creativa.
A Marco Romanelli. Molte aziende, immagino un po’ spaventate, hanno risposto a un mercato poco comprensibile con un sistema di oggetti che non lavorasse sull’eccellenza ma sullo spirito di squadra. Molto spesso i pezzi del Salone sono ormai pezzi da sfilata e non funzionano più rispetto all’architettura degli interni. Per me e per noi di Abitare questo legame tra design e architettura degli interni è una delle storie fondamentali italiane. Il design dovrebbe essere sperimentato e valutato all’interno dell’architettura, con un travaso continuo di competenze e di scala tra un ambito e l’altro.
Stanno sparendo i concetti
A Marco Romanelli. Mario Piazza dice: “Stanno sparendo le opere, stanno sparendo gli autori”. Secondo me, in realtà, stanno sparendo i concetti. Nel design esiste un processo che sta a monte, e voi di Domus l’avete raccontato; ed esiste un processo che sta a valle, il mobile che esce dallo showroom ed entra in una casa, e noi di Abitare cerchiamo di raccontarlo quasi sempre. Però il problema base è che ci sono stati periodi in cui gli oggetti raccontavano delle storie, esprimevano dei concetti.
A Fulvio Irace. Questa mancanza di concetti può forse significare che il design di cui noi stiamo parlando ha perso il ruolo centrale che ha avuto in decenni molto passati. E che probabilmente la maniera in cui lo stiamo raccontando è un po’ mitologica, si sentono ripetere sempre gli stessi nomi come se una specie di Omero postmoderno descrivesse un olimpo in cui ci sono capitani coraggiosi, femmes fatales, guasconi, maestri. È diventato una sorta di mondo un po’ circolare dove ogni anno ci si ritrova, si fanno consuntivi, si misura il tasso di perdita o di guadagno di qualità degli oggetti, si fa la conta. Bisogna allora chiedersi se il Salone di Milano sia il design o una parte di un fenomeno più vasto; se quello di cui stiamo discutendo è un pezzo molto appariscente – per tutte le connotazioni di carattere teatrale, per l’eccezionalità della concentrazione di una festa – all’interno di un sistema più vasto, direi anche più sfuggente, non necessariamente migliore. C’è poi inevitabilmente una forte componente mediatica pubblicitaria, autopromozionale, capitalistica, che bisognerebbe forse decidersi a considerare con un po’ di realismo cinico, senza meravigliarsene ogni volta. Ci sono momenti di crisi molto forte, come la mutazione della figura dell’imprenditore. Ma il fatto che gli imprenditori si siano trasformati, non siano più quelli che hanno fondato il design negli anni Cinquanta, è un fatto generazionale, appartiene a un destino biologico dell’umanità? oppure c’è stata una mutazione della figura dell’imprenditore, e di conseguenza anche di quella dell’autore, e della nozione stessa di utilizzo dell’oggetto in senso culturale? Mi chiedo quale posizione bisognerebbe assumere per provare a ridefinire questi interrogativi su cui dibattiamo in maniera abbastanza concorde, cercando almeno di definire un quadro logico che ci aiuti a capirli meglio.
A Beppe Finessi È evidente che il nostro è un mondo di quattro anime e di pochissime cose, di pochissimi numeri, un microcosmo rispetto alla realtà; è ovvio che ci occupiamo di quattro cose fatte sempre da noi e per noi. Ma se cominciamo a spostare il punto di vista, il che è molto interessante, dobbiamo dotarci di strumenti e compagni di strada nuovi ma accorti, perché non c’è nulla di più imbarazzante di leggere a volte – non sulle nostre riviste, va da sé – pareri sul Salone del Mobile, o su quello di cui noi quasi quotidianamente ci occupiamo, espressi da persone non solo lontane da questo mondo, il che è positivo, ma prive di ogni tipo di strumento critico. Non vorrei dire “se non si teleguida”, ma se almeno non si costruisce con questi nuovi interlocutori un momento “istruttorio”, normalmente il giudizio sul nostro mondo risulta assolutamente privo di senso. Accompagnato al Salone qualunque di questi “esperti” apprezzerebbe cose per noi impubblicabili, incolte, brutte, grevi.
A Marco Romanelli. Prima dicevo che oggi sono volati via i concetti e quindi tutti noi facciamo molta più fatica, perché in realtà ci arrampichiamo sugli specchi. Non esistendo più un cuore forte, una forte emozione da difendere, una bandiera da tenere alta, tutto è più faticoso. Quando eravamo a Domus, nel 1986, i concetti erano molto forti, molto violenti e molto violentemente espressi: per noi esisteva una lotta, che era la lotta al Postmoderno. Quindi era tutto più facile.
Le aziende
A Beppe Finessi. Mi pare che il problema siano le aziende, cioè gli imprenditori. A parte casi eccezionali, molte aziende non esistono più, o comunque hanno mutato il loro obiettivo. Molte si sono livellate, magari verso l’alto, ma si sono anche omologate, e oggi hanno un’immagine più appannata. Esiste poi il problema del passaggio di generazione. Le aziende che hanno fatto una certa storia di questo strano mondo che è il design – non solo italiano, ma molto italiano – sono inevitabilmente arrivate a un passaggio generazionale. In questo cambio è successo anche qualcos’altro. Il sistema “a piccola scala” ha funzionato con determinate regole fino a una certa dimensione, anche di fatturato. Quelle aziende hanno funzionato bene perché piccole, potendo quindi permettersi di non sapere cosa fossero il marketing e l’ufficio pubblicità, basandosi cioè su un atteggiamento di intuizione, di pragmatismo da sana provincia, di libertà, che è stato la loro forza e che oggi non è più possibile. Forse il mercato oggi parla di altri numeri e di altre cose, mentre noi continuiamo a cercare un’eccezionalità frutto della creatività, dell’intelligenza applicata, della maestria, e a guardare con occhi inevitabilmente puntati sul piccolo. Vedendo pubblicata l’azienda di sanitari da 4 milioni di pezzi, ci si rende conto che le prospettive sono completamente ribaltate. Mi è capitato di parlare con alcuni nuovi imprenditori che hanno preso il testimone dai padri, spesso con buoni risultati commerciali. Tra le righe risulta evidente che il loro obiettivo è mantenere l’azienda per qualche anno e poi venderla. In aprile abbiamo pubblicato un articolo su Poggi, un’azienda che programmaticamente non vuole essere venduta, piuttosto si spegne. Un eccesso che rappresenta però la consapevolezza e l’orgoglio, da parte dell’imprenditore che l’ha fondata, di ‘essere’ l’azienda. Invece questi nuovi capitani d’industria spesso si occupano di una realtà come potrebbero occuparsi di qualunque altra. E si arriva quindi a uno dei punti: ci sarà sempre un’azienda cinese capace di comprare l’IBM; ci sarà sempre un’azienda più grande che, un domani, troverà contenitori perfetti, non così difficili da gestire proprio perché amministrati con criteri di alta finanza, e quindi facilmente acquisibili. Le aziende storiche del mobile non sarebbero mai state in vendita a queste condizioni, nel senso che nessuno avrebbe saputo gestirle.
Design come fenomeno di massa
D Francesco Librizzi Mi sembra che il design sia già un fenomeno di massa. Esistono oggi imprenditori consci del fatto che c’è già il pubblico a cui vendere una massa di oggetti di “design”. Mai come quest’anno ho visto un turismo del design così incredibile attorno al Salone: c’erano centinaia di migliaia di persone, una proliferazione enorme di spettatori, ma anche di “autori minori”. Esistono forse su questo pianeta occhi più attenti dei nostri nei confronti del fenomeno design.
A Marco Romanelli. Il design è un fenomeno di massa a cui la massa, generalmente, non è preparata. Non credo sia vero che il Salone non è in questo momento così importante come noi, dall’interno, lo giudichiamo. Rimane un momento fondamentale. Da cosa ce ne rendiamo conto? Dalla quantità di articoli assolutamente incompetenti usciti sulla stampa, anche la migliore, in cui veniva spacciato per design qualcosa che assolutamente non rientra nelle nostre categorie di ricerca e di controllo estetico formale. In realtà il design è diventato un fenomeno di massa in seguito a un bombardamento fatto da persone non preparate. In questo senso è molto grave avere completamente accantonato la riflessione sul problema pedagogico all’interno delle scuole. Come possiamo pensare che le generazioni future riusciranno a far fronte a meccanismi sempre più complessi e stritolanti, se non potranno godere di una formazione di base?
SaloneSatellite
d Maria Cristina Tommasini. Mi è molto piaciuto il SaloneSatellite di quest’anno, ho trovato diverse cose belle, interessanti. Questo mi pare che contraddica un po’ quello che si diceva prima, che non c’è formazione. Forse c’è una buona formazione all’estero, e un po’ meno in Italia.
A Beppe Finessi. Sono d’accordo e penso anch’io che questo sia stato il miglior SaloneSatellite da qualche anno a questa parte. Sicuramente anche lo spazio nuovo, nonostante fosse meno appariscente e imponente di quello utilizzato in passato, era più strutturato, più organizzato, e ha funzionato molto bene. I giovani stranieri erano certamente di grande livello; la situazione degli italiani era invece un po’ imbarazzante. Probabilmente gli italiani molto bravi non hanno più bisogno di venire al Satellite, perché in fondo il 90% delle cose sono qui intorno; forse le antenne di tutti, anche le nostre, sono pronte a registrare i loro primi cimenti positivi, e quindi i contatti si creano subito. Mentre gli stranieri continuano a considere il Satellite come la prima e unica possibilità reale per sbarcare a Milano. E poi esiste, certamente, il problema delle scuole. Si registra l’onda lunga di scuole di straordinaria qualità in Svizzera, Olanda, Belgio; quest’anno ho visto dei giovani finlandesi molto bravi, altri che arrivano dai paesi nordici, o anche da Israele, dalla Turchia. Probabilmente si muovono cose che inevitabilmente ne producono altre di qualità, a cascata.
Equivoco sul design giovane
A Marco Romanelli. Dobbiamo fare attenzione a questo discorso sul design giovane, molto spesso una formula di cui si riempiono la bocca i vecchi, persone e istituzioni. Ogni fiera visitata quest’anno aveva il suo SaloneSatellite, perché si tratta di qualcosa che fa comodo ai vecchi, non ai giovani. Promuovere davvero il giovane design significa muoversi in un modo molto più concreto, molto più realistico, usando del denaro, dando delle reali opportunità. Se si crede veramente nei giovani, bisogna innanzitutto investire. L’impressione è che in Italia molto spesso si faccia il contrario, si chieda ai giovani di tappare le nostre lacune, le nostre mancanze a livello di cultura generale, a livello organizzativo.
A Beppe Finessi. Ha ragione Andrea Branzi che sottolinea sempre la peculiarità non certo felice per cui in Italia le aziende, salvo eccezioni, per anni hanno abbandonato i progettisti a fare la ricerca nel loro studiolo, nel loro garage, o nello studio un po’ più grande quando le cose cominciano a funzionare. Sono i progettisti che hanno continuato a sperimentare, portando poi alle aziende il pezzo da realizzare. Come osserva Marco Romanelli, i giovani del Satellite continuano a fare questo, a portare le loro speranze, i loro sogni, le loro ricerche. Oggi le aziende prima chiedono di fare la sperimentazione, poi di presentare il prototipo... Nel frattempo l’80% dei giovani cambia mestiere.
Design e arte contemporanea: la violenza dell’oggetto
A Paola Nicolin. Vorrei semplicemente aggiungere un breve commento a questa questione dei giovani o comunque della formazione in Italia. Per quel poco che ho frequentato il mondo dell’arte contemporanea, penso che il famoso “effetto design italiano” sia estremamente evidente nella ricerca di artisti italiani attorno ai 30-35 anni che non si dichiarano esplicitamente designer, ma sono legati in diversa misura a questa disciplina. Mi riferisco a persone come Patrick Tuttofuoco, per esempio, dai suoi primi lavori fino alla sua ultima mostra, “Revolving landscape”. La sua è la storia di un artista cresciuto nell’ambiente e nel mito di Mari, di Munari, che ha sempre guardato con grande ammirazione alla radicalità del loro lavoro senza tuttavia cessare di tradurne l’effetto nella contemporaneità. Ha scelto di rappresentare la propria idea di oggetto in un linguaggio diverso, che è quello dell’arte. La cosa più straordinaria che mi è capitato di vedere fuori e dentro questo Salone è la sua eco nell’arte contemporanea. Registro il dilagare di un criterio espositivo omologato, quello della fiera come sequenza di oggetti, che dal Miart è passato al Salone del Mobile senza soluzione di continuità, come un unico evento che si è abbattuto sulla città, per poi scomparire senza lasciar traccia del suo passaggio. Trovo che questa ‘violenza’ dell’oggetto, che arriva prima del concetto, si vede moltissimo anche in quella fetta di cultura contemporanea cui spesso il design si è attaccato. Molte delle mostre d’arte inaugurate durante il Salone hanno raccolto opere bellissime, ma il modo di rappresentarle e di allestirle è stato simile ai criteri ‘da’ Salone, che impoveriscono il concetto. Non è più una questione di concetto, ma di come questo viene rappresentato. Il mio non era un giudizio estetico, è solo un fatto di logica, un possibile ragionamento su come questa situazione espositiva si allarghi a macchia d’olio e diventi un principio di omologazione che tocca ogni sfera della rappresentazione.
Le scuole
A Italo Lupi. A proposito di scuole, mi pare abbastanza utile sottolineare che una delle cose più interessanti del Salone era la mostra “Post Mortem” della Design Academy Eindhoven: bella o brutta che fosse, poneva sul terreno un argomento assolutamente tabù e finora inaffrontato. Anche la scelta del luogo, la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, è stata un esempio di intelligenza. Una mostra molto olandese, ma anche molto vittoriana, dal momento che riprendeva alcuni elementi – raccoglitori di lacrime, il piccolo monile con dentro il ricciolo di capelli, la coltre che copriva le bare – che in quell’epoca venivano prodotti serialmente. L’atteggiamento molto olandese era porre sul terreno un tema che non viene normalmente affrontato. Come mai in Italia le scuole non propongono altrettanta intelligenza, per lo meno come argomento di dibattiti?
d Joseph Grima. L’Olanda è stato il primo paese che ha affrontato la questione del design concettuale, cioè partire dal concetto per trasformarlo in un oggetto, magari banale, con a monte una serie di significati. Tornando alla questione delle scuole, permettendomi una visione “dall’estero”. Penso ci sia stata in Italia una stagione veramente privilegiata per alcuni designer – che, però, erano quasi tutti stranieri. Jasper Morrison, ad esempio, ha avuto l’opportunità di lavorare con Magistretti e di conoscere un modello in cui il designer progettava in stretto contatto con il produttore. Morrison, come altri, ha poi fatto una trasposizione di queste esperienze su un modello completamente dislocato, a distanza dai luoghi di fabbricazione. In Italia, il rapporto diretto con l’artigianato, venuto meno con la deindustrializzazione, non è stato sostituito da un apparato scolastico in grado di riempirne il vuoto. D’altra parte, però, considerando l’apparato del design italiano nel suo complesso, la situazione è forse in questo momento più vitale che mai. Non penso ci siano molti altri epicentri nel mondo della critica del design altrettanto forti di queste due nostre riviste; il Salone più grande del mondo è qui; le aziende, seppure non utilizzino più designer italiani e non producano più in Italia, in gran parte sono ancora italiane. È uno strano paradosso.
A Italo Lupi. Forse in Italia non c’è mai stata tradizione di scuole vere ma di laboratorio. Persone come Magistretti o Castiglioni sicuramente discutevano non solo con i proprietari delle aziende ma anche con gli operai, ottimi suggeritori di soluzioni tecniche e formali. È venuto a mancare questo diretto contatto con una forza produttiva che aveva, e credo potrebbe avere ancora, un’intelligenza straordinaria.
Università
A Fulvio Irace. Mi chiedevo quale potesse essere il posto dell’università nella formazione dei giovani. È purtroppo un ruolo, non vorrei dire totalmente assente, ma certamente molto in crisi, che non offre propriamente né un’attività di autentica formazione, né di sperimentazione. Le facoltà di design o di arte spesso offrono risposte molto legislative, farraginose, anche nella definizione dei piani di studio. Si manifesta quindi un’incapacità di dare definizioni chiare a fronte di una volontà ossessiva di moltiplicare i corsi di laurea. Se queste facoltà fossero organizzate in maniera intelligente e diversificata, potrebbero tener conto dei loro diversi contesti culturali. Mentre invece il modello tende a essere omogeneo e diffuso, molte volte anche in competitività su scala nazionale, dal momento che esiste un mercato degli studenti. Si crea così una situazione surreale, che nasce dall’applicazione di concetti e di parametri, nati in contesti fortemente influenzati dalla produzione, a situazioni in cui invece la produzione è un miraggio mitico, lontano, vago. Il problema, che poi riguarda anche le facoltà di architettura e la loro crisi, è che siamo passati da un modello sostanzialmente umanistico, fondato su una forte artigianalità e autorialità della persona di riferimento, a una specie di esperanto europeo che forse ha distrutto quel buono di culturalmente anarchico che avevamo prodotto. Bisognerebbe capire se dobbiamo arroccarci in una posizione di difesa di valori che appartengono a un sistema che a noi è molto caro, ma che indubbiamente, se osservato con occhi disincantati, non può che apparire in estinzione, archeologico; o se invece dobbiamo fare dei passi, non so bene in che direzione, per inventarci un modello nuovo che sia in grado di dare delle risposte. Cavalcare quindi questa crisi in maniera progettuale.
Estetico e politico
d Marco Belpoliti. Io insegno letteratura italiana, ma non penso che i miei studenti diventeranno tutti degli scrittori. Analogamente, chi insegna architettura, o design, non dovrebbe pensare che i propri studenti diventeranno tutti celebri progettisti. C’è un problema. Il mestiere del designer è altamente aristocratico, mentre noi viviamo in un sistema democratico e la democrazia chiede che i prodotti vadano nelle case di tutti e che abbiano una qualità media o medio-alta. Questo è il paradosso della democrazia. Il passaggio che andrebbe fatto sarebbe tornare finalmente dall’estetico al politico, dopo che siamo partiti dalla politica e siamo arrivati all’arte. Non dimentichiamoci che personaggi come Mari, o come lo stesso Munari, venivano da un passato politico in cui l’arte era sostanzialmente il prolungamento della politica con altri mezzi. Credo che, come è successo nell’editoria, ci siano dei parametri da cui non si sfugge, sostanzialmente dettati dal marketing. Ma il marketing – ecco il paradosso – è un risultato della democrazia, non è soltanto l’effetto di un turbocapitalismo che vuole guadagnare di più. È una richiesta democratica: si vogliono raggiungere degli standard condivisibili da tutti. Mentre il mestiere di cui parliamo e i suoi prodotti sono assolutamente aristocratici. Penso alla grafica che ormai tutti fanno utilizzando il computer. Da un certo punto di vista hanno perfettamente ragione, dall’altro bisognerebbe contrastare questa tendenza. Credo che le scuole di design andrebbero chiuse, non aperte, dovrebbero essere sempre meno e sempre più difficili. Aprendo in modo democratico il futuro sarà, come lo è già oggi, dei manager e dei pubblicitari. L’unica risposta credo sia quella di passare dall’estetico al politico. Ma è una via assolutamente aristocratica: fare cose incomprensibili, non digeribili, non riportabili a canoni estetici o tradizionali. Come il titolo del film di Atom Egoyan, False verità, noi viviamo in un mondo di false verità. L’unica via d’uscita è prendere davvero di petto l’elemento politico. Naturalmente i problemi che abbiamo buttato fuori dalla porta rientrano dalla finestra, ma non possiamo ignorarli, sono problemi politici, della democrazia. La democrazia è il migliore dei mondi possibili? Io comincio a pensare di no.
Artigianato
A Marco Romanelli. L’estetico è sempre stato politico. Durante questo Salone è tornata fuori con evidenza una forza molto democratica: quella dell’artigianato. Il mondo dei marketing manager si è trovato curiosamente contrapposto a quello degli artigiani. Abbiamo così cominciato a vedere il recupero di determinati aspetti, il tentativo di ammorbidire certe linee, di raccontare certe storie. Alcuni esempi? Un lavoro come quello Bernardaud, con il concetto molto valido, ripreso da un discorso di Enzo Mari, dell’operaio che diventa designer intervenendo creativamente sul ciclo di produzione; oppure il recupero del Biscuit fatto da Royal Tichelaar Makkum con lo studio Job, anche questo un discorso estremamente preciso di tecnica artigianale; o ancora l’iniziativa voluta da Renato Soru, in cui ero personalmente coinvolto, sul rilancio dell’artigianato sardo. Non è vero che solo le aziende grandi possono permettersi maestranze raffinate. È quasi il contrario. Produrre con una tecnologia estremamente povera in Cina o in India, dove il lavoro costa meno, crea un enorme problema di controllo della qualità. Quindi affrontare queste realtà significa spesso tornare a confrontarsi con strutture primitive di realizzazione, cioè dimenticare la straordinaria capacità degli artigiani di Roberto Poggi, di Cesare Cassina. Sono le piccole aziende a fare ancora le cose a mano. Il problema di democrazia, massa, marketing, prodotto per tutti, è quindi molto complesso. La decorazione, che porta con sé un recupero dell’artigianato, potrebbe per una volta essere una via d’uscita abbastanza interessante, ed è una novità istituzionalizzata in questo Salone.
Inquinamento da design
d Marco Belpoliti. È vero, l’estetico è il politico, senza dubbio. Mai come adesso il design è politico, per questo ci sono i manager, perché politica si coniuga ancora una volta con democrazia. Credo che bisognerebbe iniziare a parlare anche dell’inquinamento da design, ma non per tornare al passato. Perché tutto deve essere disegnato? Perché tutto deve essere bello? Se volete parlare fuori dal gruppo, bisogna forse smettere di dare i voti come fanno i maestri e ammettere anche questa forma di esagerazione. Il design vive di se stesso, ed è normale che sia così, ma forse ora lo fa in maniera patologica. Una visita clinica non sarebbe male.
A Fulvio Irace. Era scritto nel destino della modernità. In fin dei conti le avanguardie si sono realizzate in una maniera inattesa. Era destino che il bello avrebbe cambiato il mondo. Sono d’accordo sul fatto che stiamo vivendo il colpo di coda di un’utopia che improvvisamente si è realizzata ma contro le nostre aspettative, questo bello non ci ha reso migliori né più felici. Però se ritorniamo al concetto di estetica, che non è la scienza del bello ma l’arte delle sensazioni legate alle forme, noi viviamo effettivamente in un momento estetico, dove il discorso del buongusto, del bello e del brutto, è sorpassato. Questa questione era stata posta con molta forza, negli anni Settanta-Ottanta, dai Radical, da Mendini. Anni, proprio a Domus, costati lacrime e sangue, in cui si rispolverava Abraham Moles, il Kitsch, pensieri totalmente squinternati nel contesto culturale italiano. Credo che dovremmo liberarci non tanto dall’ossessione dell’estetico quanto da quella del bello.
A Marco Romanelli. Ho l’impressione che anche tra di noi si continui in fondo a pensare al design come sovrastruttura. Non esistono cose non disegnate. Si può decidere di usare un non-disegno nel progetto, ma non esistono cose che una persona non progetti. Dovremmo smettere di pensare al design come alla ciliegina sulla torta: il design è la torta. Quando osservavo all’inizio che dobbiamo cercare gli oggetti quotidiani, intendevo esattamente questo. È necessario tornare a un controllo formale che significa anche una quotidianità e un’usabilità dell’oggetto. Non dimentichiamoci poi che esistono fenomeni come Muji, persone che nel bene e nel male hanno scelto filosoficamente questo tipo di strada. Forse semplicemente anche noi possiamo cercare di puntare meno sul design della ‘eccezionalità’ e tornare a considerare il design della ‘qualità’ come complesso, e quindi anche come estetico-politico.
A Beppe Finessi. I due nostri grandi angeli, Munari e Castiglioni, collezionavano oggetti a cui dare il Compasso d’Oro a ignoti, riconoscendo in essi non solo una parte di qualità, ma una parte di progetto.
d Marco Belpoliti. Collezionavano oggetti anonimi perché comunque facevano un mestiere firmato, e quindi questa era una necessità. Forse quello che si è perso, e quello che si perde, è il ritorno a un aspetto più dialettico. Negli oggetti che ha scelto Domus per fortuna non c’era nessuna necessità, li ho trovati molto casuali. Sono uno shakeraggio, un cocktail come lo fa un barman vero, senza misurini. La cosa che mi interessa di più è la cucina solare, bella perché risponde a qualcosa di etico. Per me l’etica è l’ethos, il costume. Questo paese ha perso l’etica perché ha perso i costumi, mi riferisco proprio a quelli di cui parlava Pasolini negli Scritti corsari, la forma del paesaggio, come ci si vestiva. Oggi tutto è firmato, esiste una volontà deliberata di disegnare e di segnare le cose. Questa volontà non lascia a volte spazio proprio a una casualità di cui abbiamo molto bisogno.
La nuova Fiera di Fuksas
A Italo Lupi Abbiamo parlato poco della nuova Fiera e dei fenomeni che può avere indotto, descritti a volte dalla stampa in una maniera drammatica che per mia esperienza personale non coincideva con la realtà, anche se certamente i collegamenti dovranno essere ulteriormente potenziati. Comunque i visitatori si sono spostati fuori dalla città per lunga parte della giornata, per cui Milano ha vissuto in un modo differente le giornate del Salone. Per quello che ho potuto vedere, la città si ravvivava alla sera, mentre durante il giorno c’erano meno carovane di designer vestiti di nero che la percorrevano. Cercando di dimenticare l’obbrobrio che faranno nel vecchio recinto fieristico, era molto divertente nella nuova Fiera alzare gli occhi, stanchi di troppi mobili, alle finestre alte dei padiglioni e vedere questa balena bianca che ondeggiava fuori, molto bella vista anche per segmenti, con un rallegrante senso di novità.
D Stefano Boeri Fuksas ha teatralizzato e spettacolarizzato il rituale del Salone del Mobile. La sua fiera è una grande macchina espressiva, che celebra il rituale delle folle “al lavoro” che fluiscono e rifluiscono nei padiglioni. Del resto, la visita alla fiera campionaria è sempre stata il viaggio faticoso, lungo, estenuante, di una moltitudine di individui solitari accomunati dagli stessi gesti...
A Fulvio Irace Per la prima volta abbiamo una fiera che è una città delle merci, organizzata secondo il principio di un progetto unitario, una sorta di microcittà degli scambi e dei flussi. Dall’altra parte abbiamo un polo, che fino adesso era sempre stato alternativo rispetto al caos del recinto della Fiera, che è la città, che si è offerta questa volta come una sorta di labirinto, di arcipelago di isole, secondo l’accezione ricordata da Stefano Boeri. Si potrebbe pensare, forse con un eccesso di ottimismo, che l’occasione della settimana del mobile a Milano potrebbe essere studiata, anche da un punto di vista progettuale e sociologico, come un tentativo di simulazione di una città dei creativi, quindi regolata da norme eccezionali che non sono quelle della pianificazione abituale. Non c’è stato alcun tentativo migliore di quello del Salone di valorizzazione e di promozione delle aree dismesse, di creare un carisma alla città; di rendere Milano, per una settimana, una città carismatica, come altre metropoli europee lo sono durante l’anno intero. Da questo punto di vista, il successo del nuovo polo fieristico aiuta a rafforzare questo carisma, offrendo per la prima volta al pubblico l’immagine di una creatività dentro le istituzioni: cioè, accanto al modello anarchico dell’iniziativa privata, la Fiera di Rho ha testimoniato dell’interesse dell’istituzione a presentarsi nella veste di una modernità efficiente e accattivante, non al traino, ma trainante.










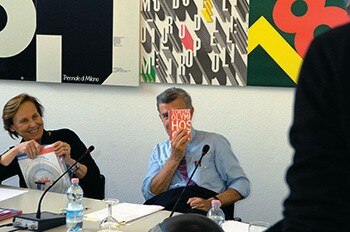



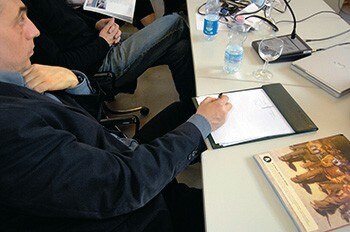
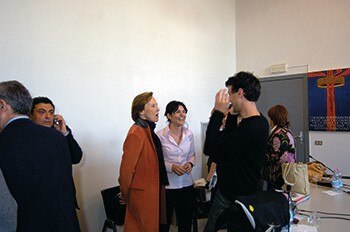


Una casa si chiude alla strada per aprirsi al paesaggio
Il progetto unifamiliare firmato da Elena Gianesini dialoga con il paesaggio vicentino, combinando tranquillità e stile contemporaneo, grazie a geometrie essenziali e alla copertura metallica Mazzonetto.









