Il calcestruzzo è il paria dell’architettura, sinonimo di edilizia sociale che si trasforma in baraccopoli. Noiose scatole architettoniche che sacrificano la bellezza al budget. È ormai il simbolo delle responsabilità dell’edilizia nella crisi climatica, con emissioni di carbonio nel mondo dal 4 all’8 per cento.
È, però, anche l’instancabile eroe del XXI secolo. È le nostre strade, i nostri ponti e gallerie. Le nostre fondamenta e le nostre fognature, le cantine e i locali tecnici, i muri e i pilastri. Anche se Copenaghen sembra interamente di mattoni, è fatta quasi sempre di elementi prefabbricati di calcestruzzo. L’impronta di carbonio che risulta dalla sua condizione di factotum dell’architettura l’ha reso il capro espiatorio ambientale, ma quando si è parte del problema bisogna avere anche un ruolo di punta nella soluzione.
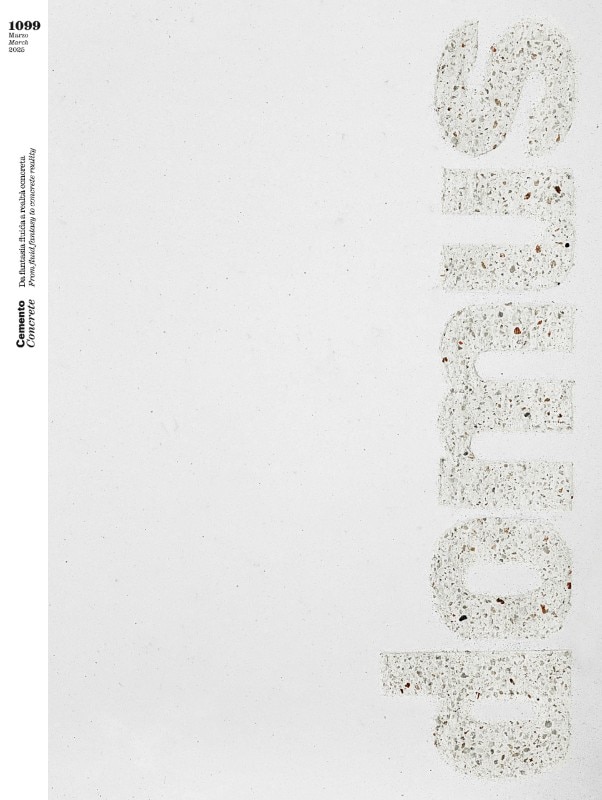
Inventato dagli antichi romani, che usavano ceneri vulcaniche del Vesuvio, è il materiale del grande Pantheon. Nell’Ottocento, un giardiniere francese si trovò a inventare il calcestruzzo armato facendo esperimenti con il tondino d’acciaio e le reti da pollaio. Il maggior protagonista della sua ascesa al rango di costruttore di città che ricopre oggi è senza dubbio Le Corbusier: i suoi cinque punti dell’architettura hanno definito in modo chiaro le libertà architettoniche del calcestruzzo. Come in tutte le rivoluzioni, ciò che parte come dichiarazione di libertà si irrigidisce inevitabilmente in inflessibile dogma. La ricerca purista di Le Corbusier sulle potenzialità del calcestruzzo è sfociata in un’urbanistica da binari per le gru. Innumerevoli periferie di tetre città satellite in cui le libertà appena scoperte si restringevano a norme, prive delle competenze e delle qualità artigianali della muratura e della carpenteria.
Quando, nel 1993, mi sono iscritto alla scuola d’arte ero avvezzo a una dieta retorica per cui il calcestruzzo era il male. È stato così fino al mio secondo viaggio di studio in Germania, Svizzera e Francia, dove incontrai un pugno di opere d’architettura che, in modi radicalmente diversi, cambiarono il mio modo di comprenderlo. Prima tra tutte l’espressività della cattedrale antroposofica di Rudolf Steiner, il Goetheanum, mi ricordò che l’inesorabilità dell’edilizia sociale in calcestruzzo non era un attributo intrinseco del materiale. Cosa che venne istantaneamente riconfermata dalla cappella di Ronchamp di Corbu, con il suo simpatico aspetto da puffo e i suoi volumi voluttuosi. Nel parco giochi architettonico del Campus Vitra fui ispirato dalla giustapposizione – quasi un ossimoro – della Stazione dei pompieri di Zaha Hadid e del Padiglione dei congressi di Tadao Ando. La prima era stata appena inaugurata ed era il primo esempio costruito della visione architettonica della progettista, fino ad allora considerata irrealizzabile.

Ero rimasto affascinato dal dinamismo futuristico e dall’espressività cromatica dei suoi dipinti architettonici. La sua opera, però, sembrava fondata su prospettive esagerate e sospettai che una versione costruita avrebbe richiesto concessioni alla forza di gravità, alla funzionalità e al budget. Mi sbagliavo di grosso. C’erano tute antincendio fluorescenti ed elmetti appesi negli spogliatoi dove i piani di calcestruzzo inclinati delle pareti, dei pavimenti e dei soffitti sembrano sfiorarsi. I sottili pilastri tubolari d’acciaio erano palesemente inadatti a sostenere le schegge di calcestruzzo sovrastanti. Il materiale che mi avevano insegnato a scartare era il segreto di questo quadro suprematista materializzato in forma costruita. Paradossalmente, però, la sorpresa più grande fu il Padiglione dei congressi di Ando. Esteriormente sembrava adeguarsi all’immagine delle scatole noiose, ma l’austera ed elegante orchestrazione di spazio e luce mi fecero capire che nell’ortogonalità può esserci fluidità. E tattilità. La superficie del calcestruzzo al tocco pareva seta, la tessitura e il colore erano simili a quelli di pietre preziose.
Tornai a casa con occhi aperti sulle proprietà quasi magiche di questo materiale controverso. Una ritrovata curiosità mi fece scoprire il Bunker archéologie di Paul Virilio: un’opera in collaborazione con Claude Parent che si era appropriata artisticamente del ready-made dei bunker nazisti, abbandonati come rifiuti sulla costa francese dopo la Seconda guerra mondiale. A Malmö mi imbattei nel chiosco dei fiori di Sigurd Lewerentz, con le sue lastre di vetro agganciate, le barriere al vapore d’alluminio a vista e i cavi elettrici sistemati come vitigni rampicanti sul calcestruzzo grezzo.
Delirious New York fece tornare i conti: Rem Koolhaas paragonava il diagramma del Metodo paranoico-critico di Salvador Dalí alle istruzioni per colare il calcestruzzo. Una goccia di paranoia informe sostenuta dalle grucce del pensiero critico. In senso più letterale, un liquido amorfo versato in una cassaforma di legno: quando si indurisce e la cassaforma è rimossa, si è solidificato nella forma arbitraria ereditata dallo stampo ormai scomparso. Sta su senza sostegno. Dalla fantasia alla realtà.
Il pensiero fatto materia.

Al momento di progettare la nostra sede di Copenaghen avevamo appena terminato degli esperimenti sul legno massiccio, efficace per ridurre l’impronta di carbonio. Il nostro sito si trovava in cima a un molo, circondato da acqua salata. La manutenzione sarebbe stata una vera e propria guerra chimica per proteggere il legno dal deterioramento. All’interno, sette piani collegati visivamente e fisicamente per eliminare la segregazione che si verifica in un ambiente distribuito su più livelli. Secondo il regolamento edilizio, solo il 25 per cento delle superfici interne poteva essere di legno. Presto fu chiaro che la strada giusta era il calcestruzzo, per motivi funzionali, economici ed esperienziali. Ci imbarcammo in un safari cementizio per scoprire come diminuire l’impronta carbonica e trovammo una miscela che sostituisce il 35 per cento del cemento con argilla e che, quando viene lasciata a vista, continua a indurirsi ricarbonizzando la CO2 dell’aria. La sua massa termica consentiva la ventilazione naturale dell’edificio e di tenere aperto ogni piano senza impianti antincendio. È evidente come investire nell’adeguamento del calcestruzzo abbia un grande potenziale per rispondere ai problemi climatici. Non riesco a immaginare un futuro senza. Questo numero è una testimonianza della sua forza e delle sue potenzialità.
Con Sublime Systems, Leah Ellis usa batteri per far fermentare la pietra calcarea trasformandola in cemento, senza i consumi energetici e il rilascio di CO2 che si verificano nella produzione convenzionale. Il fondatore di Icon Jason Ballard padroneggia costruzione robotica e la stampa 3D unita all’IA per costruire interi quartieri, e ha realizzato la prima dimora permanente sulla Luna. Philippe Block usa una raffinata modellazione e fabbricazione robotica per ridurre al minimo l’uso del calcestruzzo in belle strutture che richiamano alla mente le lastre voltate di Pier Luigi Nervi. HArquitectes ricicla il materiale di edifici demoliti per crearne di nuovi destinati a sostituirli. Christian Kerez trasforma le strutture di parcheggi in ondulati paesaggi urbani.
È evidente come investire nell’adeguamento del calcestruzzo abbia un grande potenziale per rispondere ai problemi climatici. Non riesco a immaginare un futuro senza.
Alejandro Aravena ha creato un canyon di calcestruzzo brutalista nel cuore di Lisbona mentre Thomas Phifer ha colato calcestruzzo bianco come la neve. Studio Moto ha innalzato su una spiaggia belga uno scultoreo anello di sabbia. Tham & Videgård, Pezo von Ellrichshausen e Chenchow Little Architects studiano monolitiche lastre di calcestruzzo mentre Julien De Smedt, MBL Architectes e Keisuke Oka ne sperimentano la libertà formale senza limiti. Katja Schenker lo usa come contenitore di collezioni di objet trouvé, realizzando opere simili a giganteschi blocchi di torrone. Infine, Ensamble Studio esplora l’ossimoro naturale del calcestruzzo nel suo atelier-laboratorio, dove realizzano modelli a grandezza naturale. Gru al posto di taglierine a caldo.
In un momento in cui il cemento viene più che mai criticato, credo che questo numero dimostri chiaramente come esso si trovi sull’orlo di un rinascimento sociale, ambientale e artistico. La sua plasticità gli permette di modellarsi secondo le richieste e i desideri, i valori e i voleri di un’epoca nuova. Idee astratte trasformate in realtà concreta.
Immagine di apertura: Bjarke Ingels. Foto by Wallpaper


