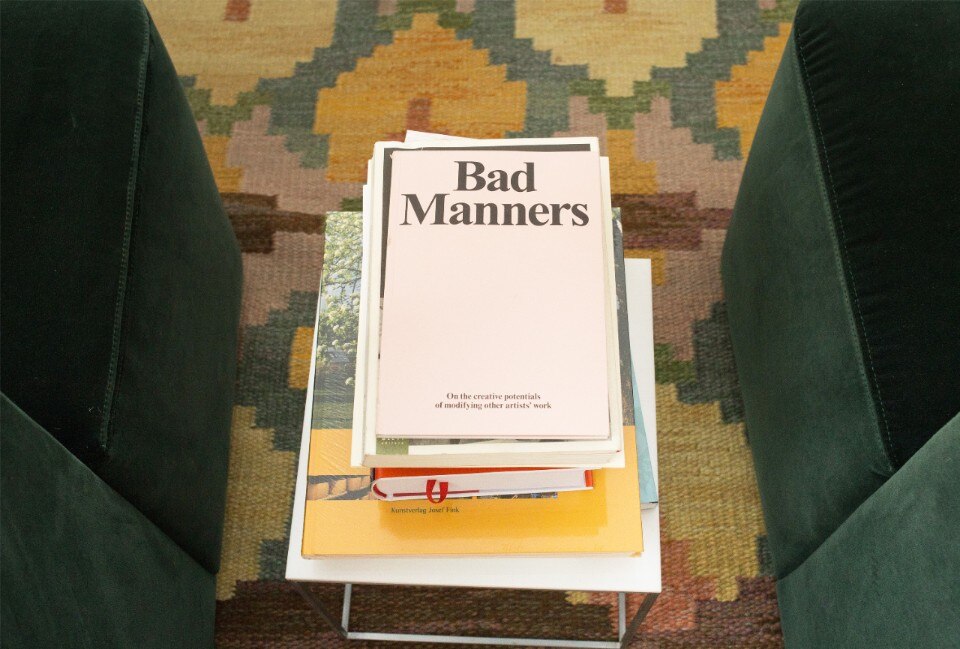“Volevo fare il fotografo, feci un corso di fotografia all’isituto d’arte di S.Francisco e poi a Parigi, ma durai un giorno, da lì aprii il mio spazio sperimentale a Milano”. L’avventura di Giò Marconi è quella di un gallerista che dalla fine degli anni ’80 cavalca la scena dell’arte contemporanea con la sua scuderia di artisti internazionali.
Ce lo racconta seduto ad un tavolo ideato appositamente per lui dall’Atelier Van Lieshout, il collettivo di Rotterdam capitanato da Joep van Lieshout, che ha dato vita a “Slave-city”, una città utopica – o distopica, a seconda dei punti di vista – progettata nei minimi dettagli, dagli edifici all’ordinamento sociale, “per arrivare ad essere quasi del tutto autosufficiente ed eco-sostenibile”, spiega Giò.
Le creazioni di J. Van Lieshout non si possono tuttavia definire utopiche, ma basate da un istinto più naïf, come suggerisce il lungo spermatozoo color puffo, lungo come la superficie del tavolo. “Quasi tutte le opere presenti in casa sono di artisti con i quali ho lavorato e non, alcuni di loro molto generosi, come John Bock, che mi regala continuamente disegni”.
Insieme alle ceramiche e ai vasi, comprati nei mercatini con la compagna, Esther, fanno capolino dei piatti firmati Alison Kats, ora in Biennale: curiosare per la casa di Giò Marconi è una sorta guilty pleasure per ogni appassionato di arte contemporanea.
“Questa è una trappola di Andreas Slominski” – dice indicando a terra – di cui molti ricorderanno la mostra in Fondazione Prada, mentre alzando lo sguardo compaiono le fiamme di un’opera di Wade Guyton, emblema di quel nuovo approccio alla tecnologia – condiviso da diversi artisti della sua generazione – per cui la soggettività dell’artista è messa in discussione, così come le produzioni più patinate, tant’è che a guidare l’esito del processo artistico diviene una comune stampante, con il suo getto d’inchiostro.
Volevo fare il fotografo, feci un corso di fotografia all’isituto d’arte di S.Francisco e poi a Parigi, ma durai un giorno, da lì aprii il mio spazio sperimentale a Milano.
È difficile non citare tutti i pezzi che costellano ogni angolo, persino del bagno, dove l’occhio cade sugli still dei video di Nathalie Djuberg, o sui disegni dei fratelli Chapman, per poi tornare in salotto dove sul tavolino, insieme ai cataloghi, appoggia un simpatico “naso-culo” firmato sempre Alison Kats, che con il suo stile scanzonato e tagliente, capovolge le convenzioni tra linguaggio verbale e rappresentazione visuale.

Una storia quella di Giò Marconi che si potrebbe iniziare a tracciare nel 1984, a Milano, quando un gruppo di giovani artisti scopre una fatiscente fabbrica dismessa e decide di occuparla momentaneamente, spinti dall’urgenza di un’espressione artistica che qui avrebbe potuto trovare un riparo, dal freddo e dai circuiti artistici più tradizionali, da cui non si sentivano compresi.
Brown Boveri fu il nome scelto dal collettivo autogestito che ben presto cominciò ad allargarsi non solo ad artisti, ma anche a ballerini, musicisti e creativi. Sebbene diversi tra loro, per radici e scelte professionali, a unirli c’era un istinto più profondo, dichiaratamente anticonformista, di voler ricostruire l’architettura di una dimensione più sociale ed urbana dell’arte.
Il caso, o forse no, volle che quel collettivo non passò inosservato agli occhi di un giovane: “C’era questa Brown Bovery, squotted da artisti ed io feci un catalogo di quell’esperienza, che portai nella galleria di mio padre”. Il giovane non era proprio un tipo qualunque, si trattava infatti di Giò Marconi, che in quell’esperimento vide forse qualcosa di più grande, quel rispetto per la storia passata affianco ad una ricognizione sulla società odierna, che di lì a poco avrebbe dato vita allo Studio Marconi 17: uno spazio laboratorio sperimentale per giovani artisti e curatori, diretto da Giò dal 1987 al 1990.

Lo Studio Marconi 17 fu solo il preludio di una nuova galleria, inizialmente guidata da Gió e dal padre Giorgio, a sua volta fondatore dello Studio Marconi (1965-1992): la galleria Giò Marconi. Una galleria che da 30 anni porta avanti una ricerca avanguardista, un aggettivo a dir poco ficcante per definire la carriera di Giò: Il termine “avanguardia” indica infatti quella pattuglia che va più avanti del grosso dell’esercito, ed è composta dai soldati più arditi e spericolati.
Ironia, intuizione e uno stile deciso, proprio di colui che anticipa, sono i tratti di una personalità, qui riflessa, seppur nella sua veste più privata: “la casa è un po’ il mio rifugio”; un rifugio che tuttavia contiene pezzi di mondo, e non stupisce, se si pensa ai 30 anni di carriera che hanno scandagliato il globo, sia a livello di ricerca che di mercato.
“A seguito di questi due anni di pandemia mi metto a rigirare, non ho mai pensato di trovare degli artisti facendo ricerca su internet, ma ho bisogno di andarli a trovare in studio.” Dopo tanti anni di esperienza, Giò ha le idee chiare su cosa smette di stimolarlo. Una risposta che è un suggello al nostro incontro, e lo descrive perfettamente: “Cercare cose nuove, trovare artisti che siano testimoni del nostro tempo”