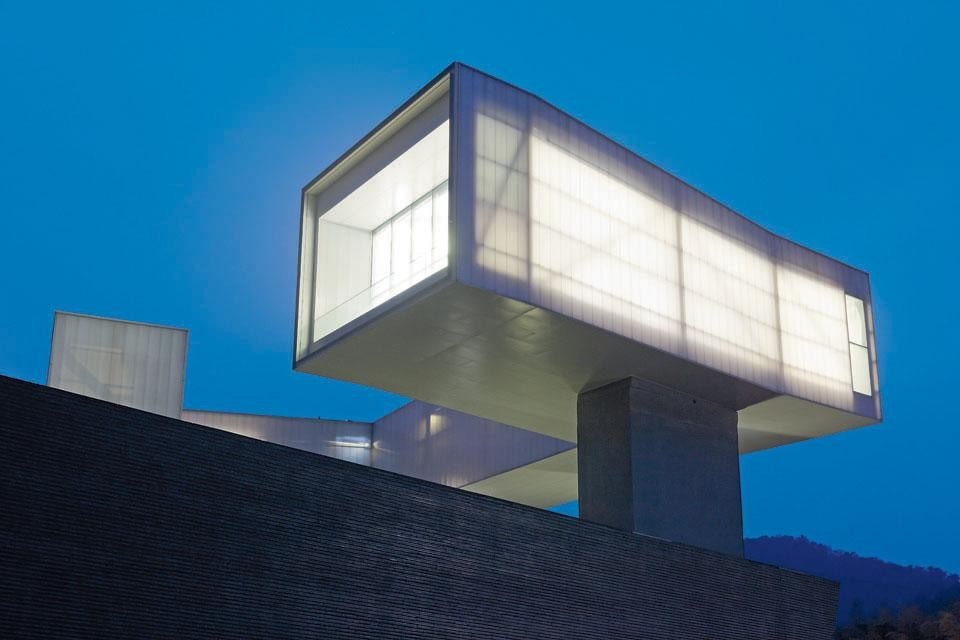Pur agendo come un’immagine, il museo genera una moltitudine di sensazioni ed esperienze non fotografabili



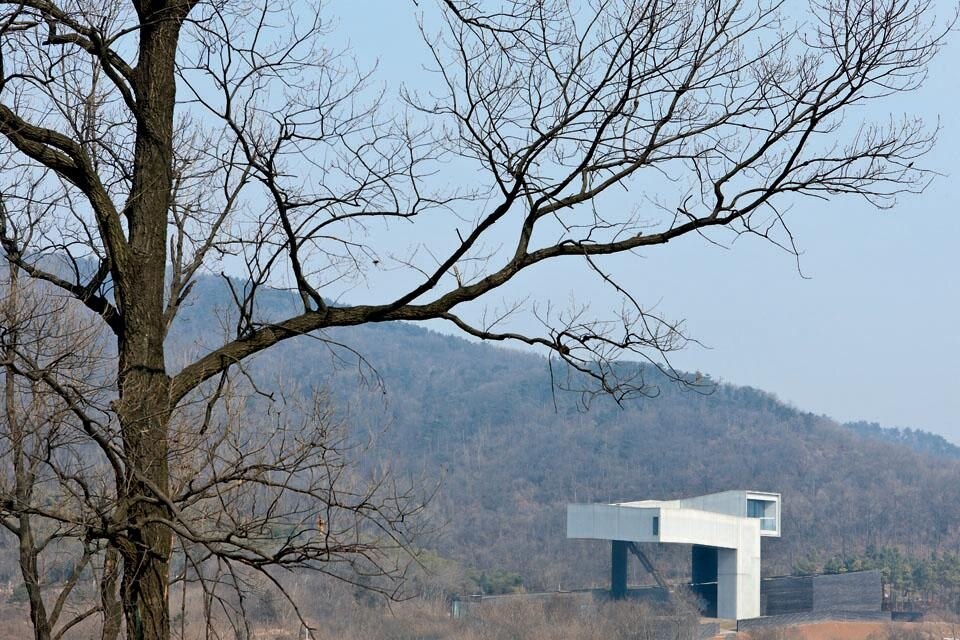
Associate-in-Charge Architect: Hideki Hirahara
Project Architects: Clark Manning, Daijiro Nakayama
Project Team: Joseph Kan, Jongseo Lee, Richard Liu, Sarah Nichols
Associate Architect: Architectural Design Institute, Nanjing University Structural engineering consultant: Guy Nordenson and Associates
Lighting design: L'observatoire International
Client: Nanjing Foshou Lake Architecture and Art Developments ltd