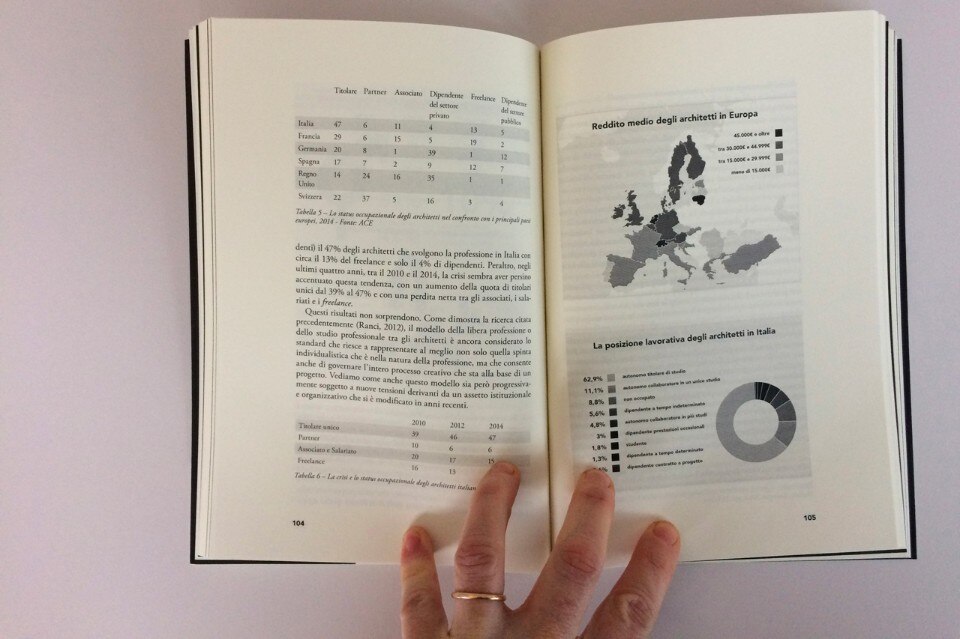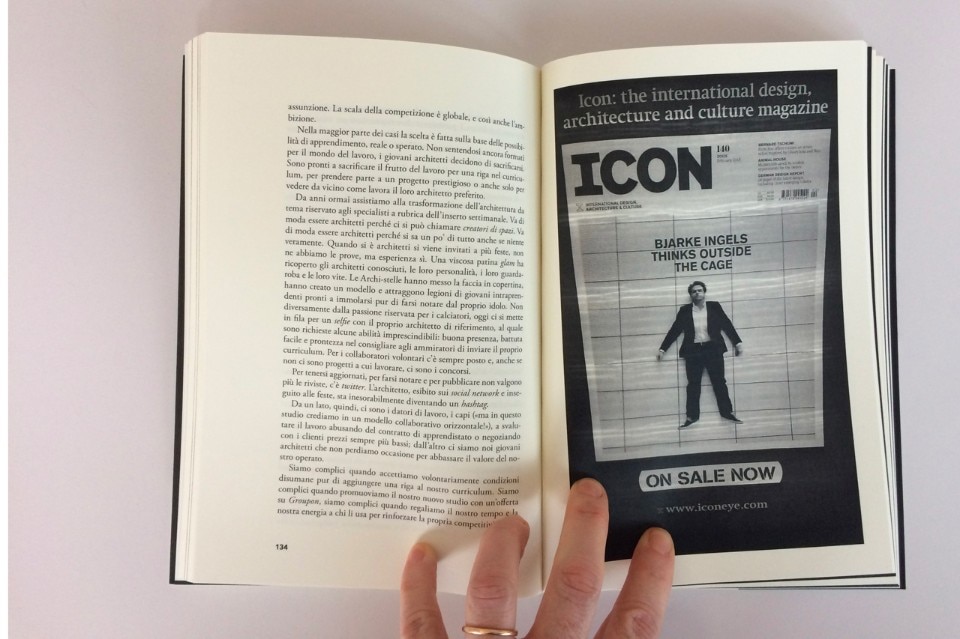Qualcuno forse ricorda l’incipit del celebre S,M,L,XL, “autobiografia scientifica” di Rem Koolhaas e del suo Office for Metropolitan Architecture pubblicata ormai più di venti anni fa, ma per molti aspetti ancora attuale. Prima del frontespizio del libro, passa in rassegna una serie di desolanti fotografie dello studio di Rotterdam, tra faldoni, cartacce, scarti di modelli di cartone, i resti di una colazione – che potremmo eufemisticamente definire “di lavoro” – e, soprattutto, un computer Apple Macintosh al centro di una generica scrivania da ufficio. In trasparenza, alcuni diagrammi appena leggibili riportano i numeri dello studio: “Forza lavoro” [Work force], “Redditi e Spese” [Income and Expenditure], “Volume di affari” [Turnover], “Spese di gestione” [Expediture], “Viaggi” [Travel behaviour] e così via. In questa cruda descrizione di cosa ci sia dietro – o meglio davanti – uno degli studi di architettura più noti al mondo c’è tutto l’ethos di un mestiere ormai cambiato.
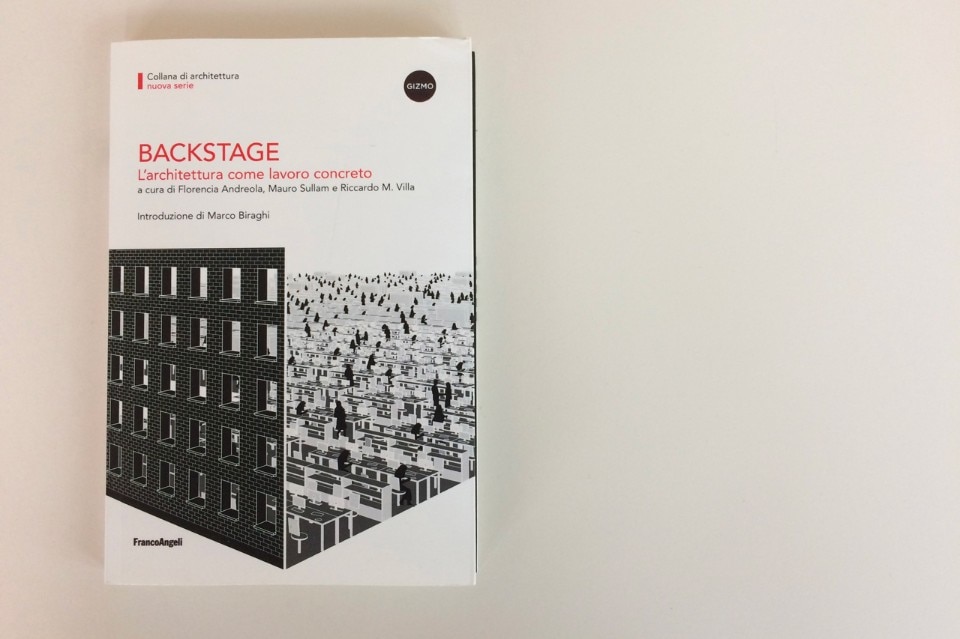
Ora, come è noto, Koolhaas è abile nel fare di necessità virtù. La coerenza imposta al lavoro dell’architetto, “cosmetica” e auto-censoria, come la definisce l’architetto olandese, è da sempre uno degli escamotage di una diffusa retorica che cerca di sublimare le difficoltà del mestiere all’insegna di un malcelato eroismo. Tuttavia, leggendo il curriculum di OMA con gli occhi delle generazioni di architetti, stagisti e freelance che, ieri come oggi, hanno reso possibile esperienze di questo tipo, non si può non percepire lo scarto epocale che ha caratterizzato gli ultimi venti anni della nostra professione.
Come se ne esce? Quello di Peggy Deamer è tra i contributi che mettono a tema una possibile strategia. Secondo la docente della Yale University il difetto sarebbe proprio nel sopravvivere di una condizione di lavoro di natura ancora fordista. Rimuovendo il mito dell’architetto come produttore di oggetti e la falsa ricompensa delle gratificazioni dell’opera d’arte, tecnologie come il BIM (Building Information Modeling) potrebbero promuovere un’idea di lavoro realmente diffusa e orizzontale – quindi più correttamente remunerato – superando definitivamente il modello Beaux-Arts basato sull’eccellenza estetica del progetto.
In attesa di valutare gli effetti dell’ennesima rivoluzione tecnologica, vale la pena ricordare che l’introduzione prima del CAD e poi di Internet, pur spostando la fase creativa nelle mani degli “operai” rendendola disponibile a fasce di addetti sempre più numerosi, non ha impedito che il loro sfruttamento diventasse ancor più sistematico e diffuso.