
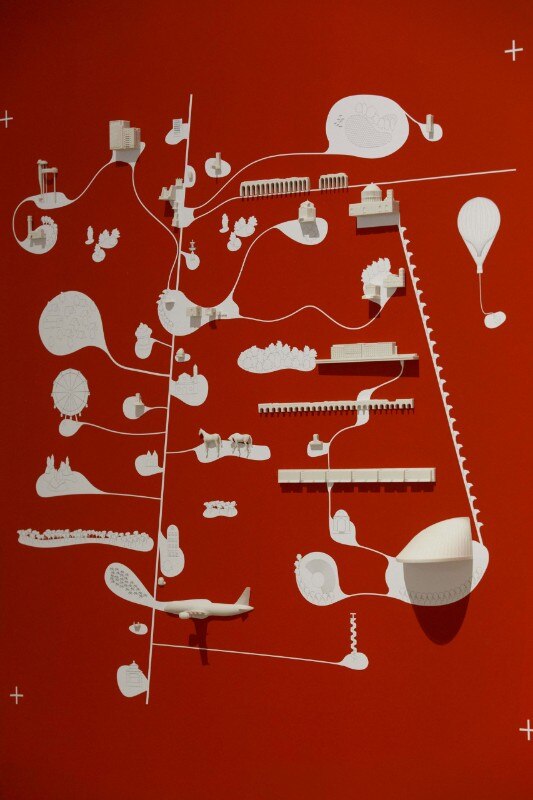






Secondo Caudo, la griglia consente di riconoscere Roma in ciascuno dei quadranti, nella molteplicità di condizioni topografiche e di paesaggio differenti, al di là di indicazioni definite a monte. Ciò che tiene insieme le differenze è infatti il suolo, non più oggi romantico “agro romano”, ma – con le sue complessità ecosistemiche, fisiche, antropiche ed ecologiche e del regime proprietario – unico elemento capace di mettere in moto i suoi potenziali cicli produttivi, nella molteplicità di forme di abitare, dall’estensivo all’intensivo. La domanda aperta è se i cittadini siano in grado (o siano interessati) a riconoscere questa complessa risorsa.
Altre capitali hanno adottato diverse scelte di metodo. A Parigi, nel 2007, Sarkozy chiese a un’equipe di 10 architetti (6 francesi e 4 stranieri) una riflessione aperta e non limitata sulla trasformazioni di una Grand Paris e mobilitò una serie di specialisti del territorio, di sociologi e geografi per cercare di capire come poteva essere nella sua interezza la Parigi del futuro, attraverso visioni complessive.

A Londra, il piano di crescita per i prossimi venti anni (The London Plan) – caso unico di città europea ancora in espansione – è stato dagli amministratori spiegato con tre concetti semplici: Londra cresce, prevalentemente verso nord-est; Londra non si espande oltre la sua green belt; l’espansione avviene solo in aree ritenute strategiche, dove il sistema dei trasporti è strutturato.
Roma ha iniziato un percorso differente e forse più complesso, comunque meno decifrabile, in cui il tema dello sviluppo urbano – non più crescita – può essere superato dall’obiettivo di un risarcimento non conservativo del paesaggio, ma in cui le singole tessere attendono una possibile ricomposizione del mosaico.


