La parola “iconico” è ormai in overdose: talmente abusata che persino lei, che ne era garante, ha perso il suo fascino. E se la parola diventa vuota ripetizione, un'etichetta che si attacca a qualsiasi cosa, lo stesso vale per molte immagini un tempo straordinarie, oggi ridotte a cliché visivi che fanno alzare gli occhi al cielo per la loro onnipresenza.
D’altronde non è una novità: con l’avvento del digitale, le immagini hanno cambiato natura. Immateriali, leggere, libere di essere trasmesse o stampate, sono ormai riprodotte senza limiti. La rete ha ulteriormente amplificato questa trasformazione, rendendo possibile una diffusione su scala e con una velocità un tempo inimmaginabili. E così, come in una convivenza forzata, ciò che un tempo brillava per la sua unicità oggi sembra soffocare. Davanti a ciò che per secoli ha tolto il fiato, l'uomo contemporaneo sussurra stanco: "Basta, per favore!"
Viviamo in un’epoca dominata dalla bulimia visiva. Se un tempo l’opera d’arte è un oggetto raro, dotato di un’aura carismatica e inimitabile, oggi ogni immagine — dal David di Michelangelo a un cappuccino ben schiumato — scorre nello stesso flusso visivo, o meglio nel feed, indistinta tra migliaia di altre.
Dai graffiti di Lascaux l’arte è esistita per condividere qualcosa (…) l’arte è il social network più antico che sia mai esistito
Francesco Bonami, Post. L’opera d’arte nell’epoca
della sua riproducibilità sociale, 2019
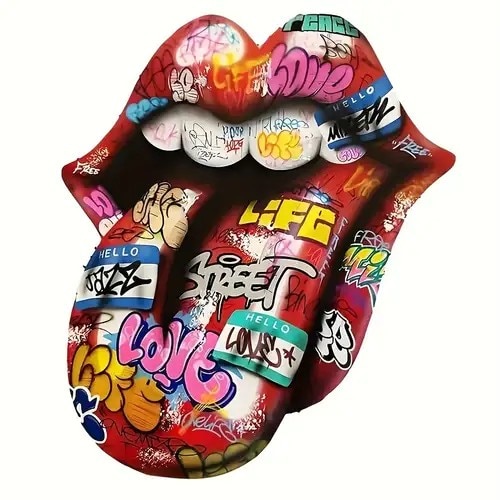
La riproducibilità tecnica, di cui parlava Walter Benjamin, diventa oggi riproducibilità virale: non solo possiamo copiare ogni immagine, ma lo facciamo in modo compulsivo. Ogni contenuto è merce in potenza, ogni sguardo si traduce in visibilità e, con questa, in valore.
Chi non si è mai trovato in un museo e, una volta davanti al tanto atteso capolavoro, ha provato un inspiegabile senso di insoddisfazione? Dopo essere stati esposti a mille riproduzioni, l’originale fatica a reggere il confronto con aspettative ormai deformate. E poi c’è l’effetto selfie: pochi secondi davanti all’opera, giusto il tempo di voltarle le spalle per immortalarsi accanto alla celebrità. Non più una calamita, un taccuino o una shopper: il souvenir più ambito è la foto con l’opera.
E se il gesto del fotografare ha sostituito quello del guardare, significa che siamo passati da uno sguardo contemplativo a uno sguardo produttivo: l’immagine non è più ciò che vediamo, ma ciò che produciamo per essere visti. E quando tutto viene visto, tutto diventa replicabile, ripetibile, dimenticabile.
Postare non ci aiuta a essere più felici ma se per caso siamo veramente felici, magari di aver visto una bella opera d’arte, postarla potrebbe aiutare altra gente a fare lo sforzo di andare a vederla allargando i propri orizzonti fisici e mentali.
Francesco Bonami, Post. L’opera d’arte nell’epoca
della sua riproducibilità sociale, 2019
Ma il culmine arriva quando un’icona si sovrappone a un’altra: basti pensare alla foto postata da Chiara Ferragni nel luglio 2020 durante una visita agli Uffizi, che la ritrae davanti alla Nascita di Venere di Botticelli. Un’immagine che divide il pubblico tra entusiasti — speranzosi che potesse segnare l’inizio di uno “svecchiamento” utile ad avvicinare i giovani alla cultura italiana — e indignati, per i quali quel gesto suonava come un’appropriazione pop superficiale, uno sfregio travestito da promozione.
L’addiction alla riproduzione crea effetti matrioska. E chissà, forse è proprio questo episodio ad aver acceso la miccia della ormai celebre campagna del Ministero del Turismo e di ENIT, Open to meraviglia, che nel 2023 trasforma la Venere di Botticelli in una vera e propria influencer: scelta per “vendere l’Italia e le sue eccellenze”.
Eccola quindi in monopattino, a farsi selfie in Piazza San Marco, in bici al Colosseo con pantaloncini blu e maglia a righe, o seduta su una scogliera di Polignano in un completo di lino azzurro, impegnata — come dichiarava il Ministro Santanché — a “portare l’Italia al primo posto nel mondo”, perché, in fondo, “siamo i più belli, ma non siamo mai stati i più bravi a promuoverci”.
Un ricordo ormai sbiadito, quello della Venere-influencer: icona tra le icone, perfettamente amalgamata al kitsch del turismo di massa. Ma proprio quando pensavate che il peggio fosse passato, noi di Domus abbiamo raccolto una lista di cose di cui davvero non se ne può più. Talmente spietata da farvi scendere una lacrima.
La Marilyn di Warhol

Poche persone al mondo sono state più “iconiche” di Marilyn già in vita: corpo, voce, fragilità, sensualità, successo e rovina. Tutto in lei era già carico, simbolico, sovraccarico di significati. Come se non bastasse, poi, arriva Warhol e la serializza. La sua immagine serigrafata nasce come risposta geniale (e un tantino cinica) al culto della celebrità e al potere mercificante dell’immagine. Un gesto critico, certo — ma il sistema ha saputo divorarlo, digerirlo, e alla fine dare ragione a Warhol.
Oggi Marilyn è ovunque: non più donna, non più simbolo. Non più immagine, ma superficie. Un pattern, quasi un vettoriale. Il simbolo dell’eccesso che diventa eccesso puro.
Il ritratto di Frida Kahlo

Frida Kahlo non aveva alcun bisogno di diventare un’icona. Pittrice, comunista, indigena, queer, disabile, tragica, potentemente viva. Ogni dettaglio della sua esistenza era già carico, politico, irripetibile, perché profondamente biografico.
Ed è proprio per questo che oggi il suo volto è ovunque — ma è diventato sorridente, floreale, stilizzato, rassicurante. Una figura storica addomesticata, ingabbiata in un’estetica folk da scaffale di "design". Non più artista scomoda, ma una santa pop da taccuino "femminista".
E no, non basterà un fiore tra i capelli per placare l’amarezza.
I baffi e gli orologi di Salvador Dalì

In un certo senso, Salvador Dalí ha fatto tutto da solo. È stato il primo a trasformare la propria immagine in un’opera d’arte: il genio eccentrico, i baffi che sfidano la gravità, i crostacei al guinzaglio, lo sguardo da folle visionario, le uscite teatrali. Più che un influencer ante litteram, è stato il precursore di quei video virali che oggi affollano le chat con gli amici più stretti.
E forse è proprio per questo che oggi è ovunque — anche dove, nonostante il suo ego, probabilmente non vorrebbe essere.
Se l’immaginario surrealista nasceva per destabilizzare, l’artista che voleva scioccare la borghesia è finito sulle copertine delle agende motivazionali.
Il paradosso più grande? Probabilmente lo adorerebbe.
Il bacio di Klimt

C’è stato un tempo in cui Il bacio di Klimt era un’esplosione dorata di sensualità, un abbraccio sospeso tra estasi e annullamento, dove forma e decorazione si fondevano in una visione mistica dell’amore.
Oggi è un cuscino. O una tazza. O un magnete da frigo. In certi casi, addirittura un mobile da soggiorno (storia vera, direttamente dal salotto di mia madre). Un tempo foglia d’oro su tela, oggi su anta di compensato.
Il David di Michelangelo

Simbolo assoluto della bellezza classica: equilibrio, forza, tensione trattenuta. Uno sguardo fiero scolpito nel marmo, pronto a sfidare Golia e i secoli. È finito stampato su boxer con messaggi tipo “100% italiano”. Testimonial della proverbiale tenacia virile del maschio nostrano.
Einstein che fa la linguaccia

Una foto scattata per gioco, a fine serata, mentre cercava di sfuggire ai fotografi - come quelle che ti fanno in discoteca alle tre del mattino, solo che la sua sarebbe diventata immortale.
Sfidiamo chiunque a ricordare un’altra foto di Einstein.
Il genio ribelle, lo scienziato fuori dagli schemi. Probabilmente voleva solo lavarsi i denti e andare a letto, mica finire su portapenne e tazze da regalo.
I Beatles che attraversano Abbey Road

Londra, 8 agosto 1969. I Beatles stanno registrando il loro ultimo album negli Abbey Road Studios e, per la copertina, decidono di uscire dallo studio e attraversare la strada. Nessuna posa, nessuna scenografia: solo quattro ragazzi che camminano in fila indiana, in pieno giorno, come se niente fosse. Il risultato? Una delle immagini più riconoscibili di sempre.
Da allora, quella zebra crossing è diventata un luogo di pellegrinaggio. Famiglie in vacanza, coppie, gruppi aziendali: tutti a rifare lo scatto, tutti con l'entusiasmo dell'essere i primi. La foto che voleva raccontare una fine (l’ultimo attraversamento prima dello scioglimento) è diventata un eterno loop visivo, senza semaforo.
Il bacio a Times Square di Alfred Eisenstaedt

È il 14 agosto 1945, la guerra è finita e a Times Square un marinaio bacia un’infermiera in un gesto impetuoso, spontaneo, travolgente. Alfred Eisenstaedt lo immortala, e quella foto diventa il simbolo della pace ritrovata, della gioia collettiva, del ritorno alla vita.
Poi succede quello che succede sempre: l’immagine si stacca dal suo tempo, si ripulisce, si edulcora. Diventa poster, pubblicità di cereali, stampa da salotto shabby chic.
E qui si aprirebbe un altro capitolo — quello sulla mania del vintage — ma rimandiamolo a un’altra volta.
La Gioconda

Se siete arrivati fin qui, sicuramente la stavate aspettando.
Da secoli osserva il mondo con quel sorriso enigmatico, sospeso tra ironia e compassione. Capolavoro assoluto, oggetto di culto, di furti, di code interminabili e selfie tremolanti. Che poi — qualcuno è mai riuscito a vederla davvero, dal vivo?
Per molti, la Gioconda è la prima vera celebrità globale della storia dell’arte. Di sicuro, è la più stanca.
I teschi messicani

Nati come simboli del Día de los Muertos, un tempo evocavano il rapporto con la morte, la memoria degli antenati, il ciclo della vita. Ora guardano il mondo da una mensola, dipinti a mano e probabilmente pieni di brillantini. Un po’ folklore, un po’ posh, un po’ troppo.
Fenicotteri e unicorni

Coppia regale del kitsch contemporaneo. Protagonisti indiscussi di gonfiabili da piscina, planner settimanali, pigiami flanellati e brunch instagrammabili. Tutto urlato, tutto pastello, tutto eccessivamente cute.
Sembravano innocui simboli di evasione — tropicale l’uno, fantasiosa l’altro — e così li abbiamo lasciati entrare ovunque. Ora sono peggio dei piccioni: non riusciamo più a farli uscire.
L'happy hour, quota milanese

Spritz, taglieri e storie da postare con leggerezza studiata. Un tempo si andava a bere qualcosa. Oggi si va a fare "aperitivo" — che, tra l’altro, è il momento perfetto per incastrare appuntamenti borderline: quelli che non sai se vorrai vedere né a cena né dopo.
Se non ci avevate pensato, pensate al lato positivo: non serve più il seltz. Ora il Campari vi sembrerà già un po’ più amaro.
La gente che salta nelle foto

Doveva essere un gesto di spontaneità, gioia, libertà — il livin’ la vida loca delle foto ricordo. È diventata un’epidemia: la foto con salto incorporato.
Squadre intere di turisti in aria, in discoteca, davanti a monumenti, matrimoni, tramonti, deserti, canyon, padiglioni della Biennale. Non sappiamo quando sia iniziata, ma da allora non si è più fermata.
Certo, ci vuole un fisico bestiale.
In semiologia, il concetto di "iconico" si fonda sul rapporto tra segno, oggetto e significato: se ogni cosa diventa iconica, allora niente lo è davvero. È il cortocircuito del nostro tempo: più immagini produciamo, più il senso ci sfugge. Il rischio è un appiattimento dell'immaginario, dove tutto sembra già visto, già scrollato, già archiviato. La vera domanda è se, nell'incessante produzione di immagini, resta ancora spazio per qualcosa di significativo e autentico — e quanto tempo gli resta, prima di trovarsi stampato su una tazza.

