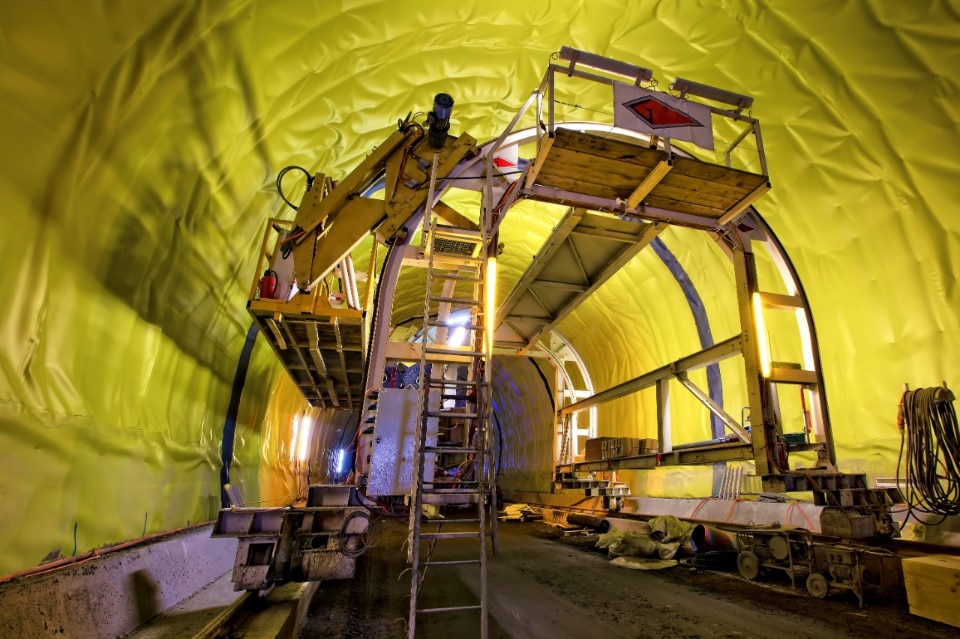La paralisi dettata dal Covid-19 ha confermato come l'interconnessione sia la vera chiave della mobilità di persone e merci, e come quest'ultima sia, a sua volta, il fattore di crescita per eccellenza.
Da decenni gli studi evidenziano la correlazione tra la performance di un'economia e la qualità delle sue infrastrutture e mai come oggi gli investimenti strategici possono essere un'arma formidabile di rilancio.
Se in Italia questo tema è rappresentato drammaticamente dal gap tra nord e sud (ma in misura minore anche tra il Paese e il resto dell'Europa occidentale), in tutto il continente sono in tanti a scontare ritardi e miopie.
In particolare la Francia, solitamente molto attenta all'interpretazione geopolitica della realtà, ha trascurato per decenni la manutenzione e la realizzazione di infrastrutture strategiche e non sorprende che questo capitolo sia da mesi al centro dell'agenda dell'Eliseo.
Investire in infrastrutture appare oggi fondamentale per tre ragioni: da un lato si tratta di un potente strumento anticiclico, in grado di rilanciare l'occupazione e l'economia dei territori in un momento in cui consumi, scambi e investimenti sono vicini ai minimi storici. Dall'altro, migliora esponenzialmente la competitività del sistema paese con ricadute capillari in tutte le sfere della produzione e del mercato. Nel gergo economico si parla di “effetto moltiplicatore”: ogni somma investita in infrastrutture genera un ritorno economico molto superiore in termini di PIL e occupazione.
Il caso scuola per eccellenza? Il New Deal di Roosevelt, lo strumento socioeconomico e legislativo che ha traghettato gli Stati Uniti fuori dalla Grande Depressione dotandoli, grazie a ingenti fondi pubblici, delle reti che li avrebbero presto resi una potenza globale.
Infine, se le opere strategiche sono materia di export, l'infrastruttura diviene un veicolo formidabile di influenza economica e culturale. In altre parole, di soft-power.
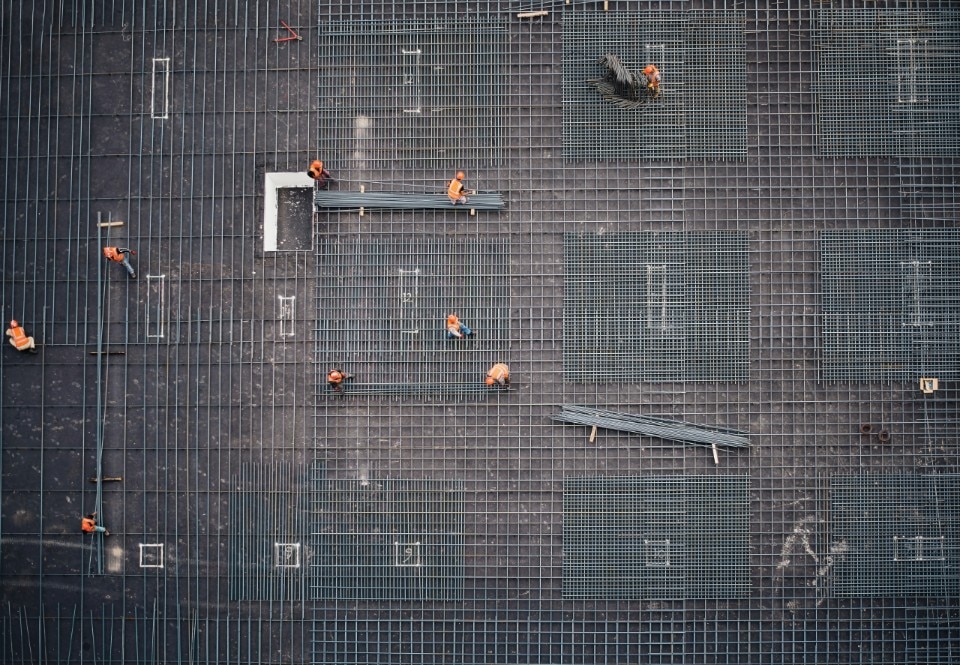
Lo sa bene la Cina che sulla colossale serie di infrastrutture denominata Belt Road Initiative, detta anche – Nuova via della seta – ha puntato molte delle proprie fiches sul tavolo dell'egemonia globale, un progetto non a caso avversato con forza da Trump e prima ancora da Obama.
La pandemia ha però inferto un duro colpo alle ambizioni di Pechino, forzando lo stop dei cantieri in giro per il mondo e bloccando le forniture di materiali.
La crisi della Belt Road è acuita anche dal modello gerarchico cinese che punta su risorse umane e materiali esportati direttamente dalla madrepatria piuttosto che sulla delega e il reperimento in loco.
Ma c'è di peggio: molti paesi, specialmente in Africa, sono oggi in crisi e dunque impossibilitati a onorare i debiti contratti con il Dragone. Così il rischio che i progetti vengano definitamente abbandonati è reale.
Le ambasce della Belt Road fisica però non bastano a frenare l'azione del governo di Xi Jinping sul tema infrastrutturale, ma semmai lo faranno virare verso il digitale: mentre cerca di esportare il proprio soft-power tramite il cavallo di Troia Huawei, Pechino fa passi da gigante anche in campo satellitare con l'espansione del sistema Beidou, nato nel 2000 come risposta alla tecnologia americana del GPS.
Il lockdown d'altronde ha evidenziato un po' ovunque proprio l'importanza delle infrastrutture digitali come le reti di fibra ottica e i ripetitori, e messo in luce la debolezza dei cosiddetti deserti digitali. Sul piano geopolitico poi è sempre più cogente il tema della localizzazione dei centri dati e della sicurezza digitale, come l'affare 5G illustra perfettamente.
In questo contesto la cultura del progetto è chiamata a un drastico cambio di marcia. Le regole del nuovo gioco prevedono il ribaltamento del rapporto tra infrastruttura fisica e digitale, con la prima che deve nascere necessariamente in funzione della seconda e quest'ultima che deve essere orientata a ridurre i consumi grazie ai big data e agli algoritmi predittivi.

E poi c'è il tema della sostenibilità, da abbracciare senza esitazione in un settore, quello delle infrastrutture, responsabile di oltre il 70% delle emissioni globali di gas serra (tra costruzione e funzionamento).
Un ruolo particolare l'avranno gli urbanisti. Secondo il Dipartimento di Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UNDESA) nei prossimi dieci anni la popolazione mondiale passerà dagli attuali 7,5 miliardi a quasi nove e quasi due terzi delle persone vivranno in aree urbane.
Se da un lato la maggiore densità riduce il costo delle infrastrutture e dei servizi ai cittadini, dall'altro rappresenta una grande sfida per gli urbanisti che dovranno evitare la trappola della diseconomia di scala contemperando le esigenze economiche, quelle sociali e – lo stiamo imparando – quelle sanitarie.
Coinvolgendo nel dibattito gli specialisti della progettazione, gli esponenti delle scienze sociali, dell'impresa, della finanza, delle istituzioni e del terzo settore, domusforum 2020 si propone quale piattaforma di confronto sul tema.
Alla ricerca di una sintesi e dunque di un percorso che conduca la nostra società non solo fuori dalla pandemia ma anche oltre le secche di una crisi sociale ed economica nella quale dibatte da tempo e che il virus sta soltanto esacerbando.