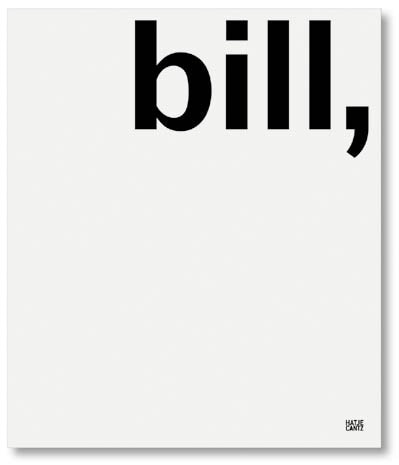Max Bill Maler, Bildhauer, Architekt, Designer, A cura di Thomas Buchsteiner ed Otto Letze Hatje Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit 2005 (pp. 296, € 34,00)
Max Bill è il paradigma dell’artista universale. È più breve escludere i campi della produzione artistica e visiva in cui non abbia operato, che elencare quelli dove abbia svolto fattivamente, per quasi un secolo (1908-1994), una costante ed instancabile attività. Proprio per questa ragione, nel recensire (sulle pagine di Domus 880, aprile 2005) un numero monografico della rivista spagnola 2G su Max Bill Arquitecto, Federico Bucci sottolineava con un tono molto severo, che un libro esclusivamente incentrato sul Bill architetto “risulta essere irrimediabilmente privo di quella ‘complessità’ necessaria per comprendere la sua opera”.
Sembra voler rispondere a questa esigenza la monografia edita dalla casa editrice tedesca Hatje Cantz, curata da Thomas Buchsteiner e Otto Letze, con l’apporto tra gli altri di Gerd Fleischmann e Jakob Bill. Il volume dalla copertina bianca reca infatti un titolo molto promettente e ambizioso: Max Bill, pittore, scultore, architetto, designer, ma potrebbe continuare con grafico e tipografo! Mi pare che il pregio e al tempo stesso il limite del libro stia proprio tutto in questo. Se tuttavia ed inevitabilmente si finisce con il rischiare l’accusa di ‘incompletezza’, lo sforzo di inquadrare, per così dire sotto un unico riflettore, una figura così variegata e complessa come quella dell’architetto svizzero è forse uno degli approcci più credibili e condivisibili.
Singolare resta comunque il fatto che Bill, nonostante riconoscimenti e premi quale pittore e scultore (vanno ricordati tra tutti “Gran premio” alla Biennale d’arte di San Paolo in Brasile nel 1951 ed il “praemium imperiale” a Tokyo nel 1992) di sicuro maggiori di quelli che critica e pubblico hanno riservato alle sue realizzazioni in architettura, non ha mai fatto mistero di preferire per sé il titolo di architetto. L’influenza che Max Bill, in particolare negli ultimi decenni, ha esercitato su alcune delle nuove generazioni di architetti, soprattutto in Svizzera, pare avallare questa sua scelta.
Nel 1996, in occasione della XIX Triennale di Milano, un volumetto dal titolo Minimal tradition ha messo in luce evidenti ‘corrispondenze’ tra il maestro e le cosiddette nuove leve. Esemplare è il caso di Marianne Burkhalter & Christian Sumi, con il loro Kindergarten Lustenau (1992-93), chiaro riferimento al progetto di Bill per il Padiglione svizzero alla Biennale di Venezia del 1951, piuttosto che quello dei zurighesi Annette Gigon e Mike Guyer con il Kirchner Museum a Davos (1991-92). Ma non mancano gli Herzog & de Meuron dei primi lavori fino a Peter Märkli e ai Diener & Diener di Basilea. Allo studio dell’architettura Max Bill arriva folgorato da una lezione di Le Corbusier. Nel 1927 si iscrive al Bauhaus di Gropius, rimanendone in qualche modo legato con un filo invisibile fino al giorno prima della sua morte.
Membro del Bauhaus-Archiv di Berlino, lo ha diretto infatti dal 1985 fino al 1994. Dessau significa anche l’incontro con i più grandi artisti e rappresentanti dell’avanguardia. Sopra tutti quello con il conterraneo Paul Klee e naturalmente quello con Vasilij Kandinskij. Ecco allora che la prima parte del volume non poteva prescindere da questo rapporto indubbiamente decisivo. Un estratto, da uno scritto del 1951 dello stesso Bill su Kandinskij pedagogo ed educatore, apre il volume e chiarisce, non solo in maniera simbolica, dove vanno rintracciati i germi iniziatori di tutto il percorso billiano. La grafica ricercata e nitida non nasconde i propri debiti e rimandi verso l’attività di Bill tipografo, grafico e curatore di testi importanti di architettura (nel 1939 cura Le Corbusier & P. Jeanneret, OEuvre complète 1934-1938). La struttura del libro prevede a capo di ogni capitolo, in modo conseguente dall’inizio alla fine, un testo di Max Bill seguito dai relativi saggi critici sull’argomento.
La mancanza di una bibliografia ragionata è, possiamo dire, mitigata dai numerosi riferimenti bibliografici a margine di quasi tutti i contributi scritti. La validità e la scientificità dei testi sono indiscutibili. E non sorprenderà più di tanto ritrovare il testo di Gerd Fleischmann su Bill tipografo, che ai lettori di Domus risulterà familiare, essendo apparso quasi identico sul numero 811 della rivista di gennaio 1999. Se si accetta l’ipotesi che lo sforzo intellettuale per capire l’opera di Max Bill non può non avvenire a tutto tondo ed intersecare analiticamente e simultaneamente i diversi terreni dell’arte in cui si è cimentato, paradossalmente occorre prendere atto che lo stesso Bill ha sempre affermato con convinzione di voler distinguere le varie sfere del suo fare.
Per superare questa contraddizione in termini e a conferma di una linea transversale che lega i temi formali dalla pittura all’architettura sostenuta da Hans Frei, Stanislaus von Moos ha proposto la tesi che in fondo per Bill “l’unità dei metodi e la pluralità delle forme sono le due facce della stessa medaglia della creazione concreta”. Rifiuto totale dell’arte come rappresentazione è il fondamento dell’arte concreta, di cui Bill è stato uno dei protagonisti indiscussi. Con Bruno Munari e gli altri esponenti del MAC, organizza a Milano nel 1947 una delle più importanti e famose rassegne di arte concreta. La documentazione sulla scultura e sulla pittura, in Bill sempre contrassegnate da un costante richiamo ai concetti della matematica, ma anche della geometria e della fisica, offre al lettore una vasta scelta di opere, che vanno dai primi lavori degli anni Venti in cui aleggia l’ombra di Paul Klee fino alle opere frutto di calcolate geometrie e contrappuntate da reiterati studi cromatici.
Della sua scultura elementare del 1935, la cosiddetta “unendliche schleife” (la curva infinita), scriverà più tardi che “quella scultura rappresentava, in forma artisticamente interpretata e calcolata, il nastro di Möbius, ben noto in matematica”. L’artista-intellettuale e critico Max Bill è anche un estenuante teorico. Gli scritti accompagnano la sua opera. Il tema della forma è centrale. Su questo nasce la conferenza del 1948 sulla “Bellezza dalla funzione e come funzione”. Segue la mostra-manifesto “Die gute Form”, a Basilea nel 1949, che vuole essere la risposta, in termini di rifiuto, allo Styling nel campo del disegno industriale.
Questo impegno, visto quasi come una missione, e il ruolo carismatico di fondatore della Hochschule für Gestaltung di Ulm, nei primi anni Cinquanta, insieme ad Inge Scholl ed Otl Aicher, non potevano mancare in una trattazione che si presuppone poliedrica su Max Bill. Nel capitolo dedicato ad Ulm ed alla scuola, Eugen Gomringer, l’allora segretario personale di Bill ed attuale direttore dell’Istituto per l’arte e la poesia concreta di Rehau, si interroga cercando di trovare una risposta su come mai l’arte non rientra nel piano degli insegnamenti.
Le molteplicità delle chiavi di lettura sono evidentemente tante e l’esperienza della Hochschule für Gestaltung di Ulm è diventata un vero e proprio caso, che ha diviso studiosi e critici dell’architettura e del design. Certo è che le polemiche, nate dopo poco tempo al suo interno, sono state comunque la testimonianza dell’impegno e della passione dei suoi protagonisti. E se si vuole, anche il segno delle difficoltà contenute nelle premesse, ovvero quelle di voler concepire la scuola come continuazione, seppure riveduta, del Bauhaus. La risposta che Max Bill fornisce riguardo ai problemi della produzione di oggetti su scala industriale, e il suo strenuo richiamo al tema della forma, non lo hanno risparmiato da critiche, come quella di Tomas Maldonado per un certo “formalismo implicito nella gute Form…”. Superata la regola classica “la forma segue la funzione“, sempre secondo Maldonado, Bill presuppone “una impostazione dinamica del rapporto forma-funzione” in cui forma e funzione “non hanno un rapporto lineare, successivo e continuo, ma parallelo, simultaneo e discontinuo”.
Conclude il libro un immancabile ritrattoomaggio fotografico dell’artista. Tra le belle fotografie, tutte in bianco e nero, scorriamo la vita di un protagonista del Novecento. Una di queste, scattata dalla sua giovane moglie Binia Spoerri Bill, violoncellista e fotografa, allieva di Lucia Moholy alla Ittenschule di Berlino, mostra un giovane Max Bill, inizio anni Trenta con appena alle spalle l’esperienza decisiva del Bauhaus. Non va dimenticato che proprio Binia Bill è stata una sorta di testimone per immagini di questa controversa figura. Definito dai curatori del volume “homo universalis” dell’arte, all’artista Robert Wilson piace ricordarlo così: “Max was bill, bill was just bill, simple simply bill, a philosopher simple”.
Antonello Ferraro Architetto