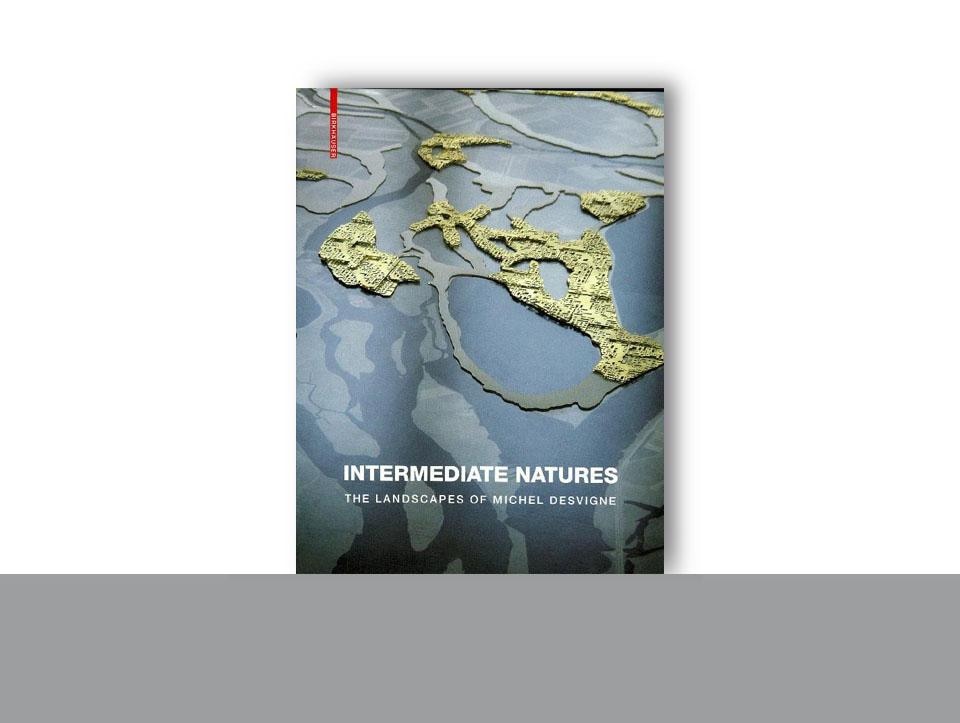Michel Desvigne con contributi di James Cornere Gilles A. Tiberghien, Birkhäuser, Basel 2008 (pp. 200, s.i.p.)
In apertura James Corner rilegge il lavoro di Michel Desvigne attraverso tre categorie: Agricolture, Texture, Unfinished. La prima si porta dietro tecniche e saperi ben fondati. La seconda scompone definitivamente la relazione modernista figura-sfondo. La terza parla del tempo. Poi, lo stesso Desvigne, suggerisce altre connotazioni: il legame tra rigore e innovazione al di fuori da facili scorciatoie; l'uso di prototipi dove sperimentare densità e gestione delle coltivazioni; la costruzione di vocabolari utili alla definizione di nuovi spazi pubblici; l'idea che il sistema dei parchi funzioni come infrastruttura urbana; il rifiuto delle facili retoriche della sostenibilità, dell'accezione statica ed estetica della nozione di paesaggio; la passione per Olmsted e quella per la geografia. La percezione netta dello scarto nel tempo tra coltivazione e costruzione.
Evidente la distanza tra Intermediate Natures e la ridondante letteratura di paesaggio: nell'importanza data alla cornice teorica; nel rilievo assunto dalla parola scritta; nella misura e nel carattere dell'apparato iconografico. E, naturalmente, nei progetti presentati. Progetti che si prestano a un gioco. Dimenticando per un momento libro e autore, potremmo ascriverli contemporaneamente a due traiettorie distinte. Riconoscere due differenti genealogie. Quella della progettazione territoriale, dei suoi materiali, delle sue figure. Quella della progettazione di paesaggio, della botanica, delle tecniche derivate dall'agricoltura. Desvigne sottolinea spesso la divaricazione quando scrive del piacere della domesticazione di siti come qualcosa di diverso dal piacere della costruzione. Si muove con materiali intermediate. Maneggia il tempo più che prevederne le conseguenze. Insiste sulle tecniche di coltivazione, su pochi materiali elementari: erba, superfici mineralizzate, acqua, piante. Doppie genealogie dunque. Saperi diversi e un differente profilo del progettista: esploratore, non certo urbanista.
Ma il doppio ha un punto di sovrapposizione in cui le differenze sembrano annullarsi. Le domande che si pone Desvigne sono le stesse che si pone l'urbanista: come leggere le trasformazioni della città contemporanea? Come dare coerenza a un territorio frammentato? Come restituire allo spazio pubblico il carattere di uno spazio comune? I suoi progetti, come quelli urbani, tendono a un migliore funzionamento del territorio. Danno risposta a esigenze elementari: proteggersi dal vento, circolare meglio, garantirsi la luce del sole, costruire descrizioni che diano significato ai luoghi, aprano l'immaginazione. I discorsi fanno volentieri riferimento a un organicismo noto. E poi, nell'un caso come nell'altro il progetto ha a che fare con la cosa pubblica: forma territori che sono beni comuni. Il paesaggio è produced by society, non certo esito di una visione privata. Il compito del progettista è contribuire a una trasformazione, mostrare un differente modo di abitare. Su questo terreno, le due traiettorie si confondono entro lo sfondo di un pragmatismo critico che rilegge il progetto come indagine sperimentale, orientata a trattare problemi pubblici, mai stabiliti a priori. Lavoro che può giungere a una ridefinizione del senso e della forza dei problemi e a loro soluzioni. Senza tuttavia che ciò sia garantito.
Quello del doppio che trova un punto di convergenza non è un gran gioco: è da venti anni che il progetto urbano è riscritto in paesaggio. Tanto che sarebbe utile smetterla di coniare nuovi neologismi che mescolano la parola landscape con tutto. Progetti territoriali e progetti di paesaggio sono perlopiù indistinguibili. O meglio, si distinguono su un altro piano: possono essere buoni o cattivi progetti, affrontare con sapienza e intuizione qualche problema o essere esercizi manieristi, che riproducono atteggiamenti. O ancora dogmatici o neo-positivisti come in tanta ecologia di ritorno. Ma il doppio ricompare nel momento in cui si cerca una legittimazione per l'azione Qui si ritrova una nuova divergenza. E si apre la possibilità di un altro esercizio: osservare "la tirannia dei valori" (come direbbe Schmitt) nel campo del progetto e del discorso sul paesaggio. Valori che sono sempre contraddetti da altri valori, che sono posizionati (qualcosa vale di più, di meno, vale contro qualcosa d'altro). Anche quando quel qualcosa riguarda la natura, il territorio come bene comune, il paesaggio come forma di umanesimo. Valorizzazioni e svalorizzazioni reciproche, che si rendono reali attraverso le mediazioni del pensiero tecnico. Valori che si cerca di imporre anche solo nominandoli. Poiché (ancora Schmitt) "chi ne sostiene la validità deve farli valere". La legittimazione è dunque, di nuovo, una divaricazione. Una lontananza (nei valori) che rimanda a un'assenza di lontananza (nelle pratiche). Una distinzione costruita su un'assenza di distinzione. Su una distanza che non c'è. È nelle genealogie, nelle appartenenze, nei valori. Ma non nel fare. Un ossimoro di quelli che sarebbero piaciuti a Bourdieu.