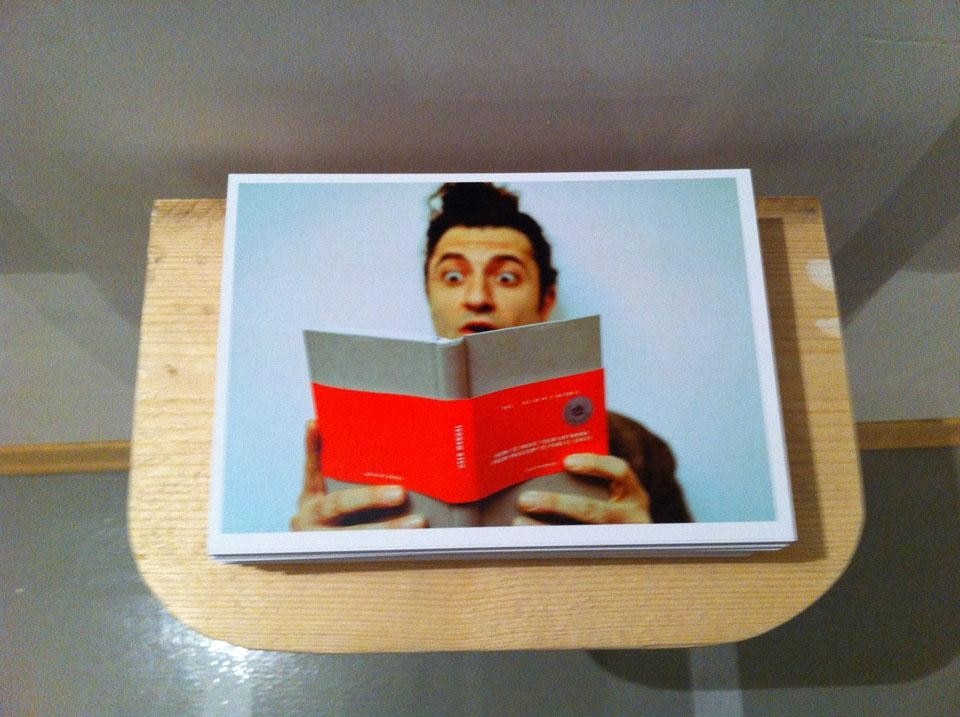Quali sono i caratteri di novità di questa residenza?
Viadellafucina propone un format del tutto inedito e sperimentale che nasce con l'intento di rendere le esperienze di residenza maggiormente produttive, sia per gli artisti ospiti sia per il territorio di riferimento. A partire dalla mia esperienza personale di artista che ha partecipato ad altri programmi di mobilità, ho cercato di ragionare su come innovare radicalmente un modello consolidato per favorire l'integrazione dell'artista ospite, da un lato, e lasciare una traccia tangibile nella comunità ospitante, anche in termini di produzione di conoscenza, dall'altro.
L'aspetto di sostanziale novità è costituito dal dispositivo del gemellaggio: per partecipare al nostro bando abbiamo richiesto ai candidati di costituirsi spontaneamente in coppie, ciascuna composta da un artista straniero e da un artista torinese, intenzionate a lavorare e a produrre un progetto a quattro mani che interessasse il territorio specifico in cui opera Kaninchen-Haus: il quartiere di Porta Palazzo a Torino. La presenza nella coppia di un artista già attivo nella nostra città ha permesso agli artisti stranieri di entrare velocemente in relazione con la comunità locale e di riuscire a decifrarla. Al tempo stesso gli artisti torinesi si sono avvantaggiati di una grande opportunità di formazione peer-to-peer costituita dalla possibilità di collaborare con colleghi formatisi in un contesto internazionale.
La felicità di questa intuizione è confermata dal fatto che tutti e tre i progetti selezionati prevedono in qualche modo un proseguimento.

Quando alcuni anni fa venni invitato a partecipare alla mia prima residenza ero partito carico di entusiasmo con l'idea di trasferire la mia progettualità in un contesto totalmente nuovo e, soprattutto, con l'illusione di riuscire a stabilire un contatto comunitario con altri artisti. L'esperienza che avevo vissuto era stata però profondamente diversa. Il contesto offerto dalla residenza assomigliava a quello di un non-luogo. Difficile era, in un breve lasso di tempo, penetrare nel contesto della città che mi ospitava. Altrettanto difficile stringere legami con gli altri artisti in residenza, quasi tutti già adagiati sull'idea di interpretare la trasferta come una mera opportunità professionale. Infine, l'unico contesto con cui venivo messo in contatto dall'istituzione era quello del mondo dell'arte: un microcosmo per me piuttosto noioso e soprattutto sempre simile a se stesso, indipendentemente dalle coordinate geografiche.
Questa globalizzazione del formato è sicuramente il sostanziale punto debole di quasi tutte le residenze internazionali. Ciò che rende Viadellafucina un'esperienza autentica è sicuramente il fatto che sia un programma nato da artisti in favore di altri artisti.
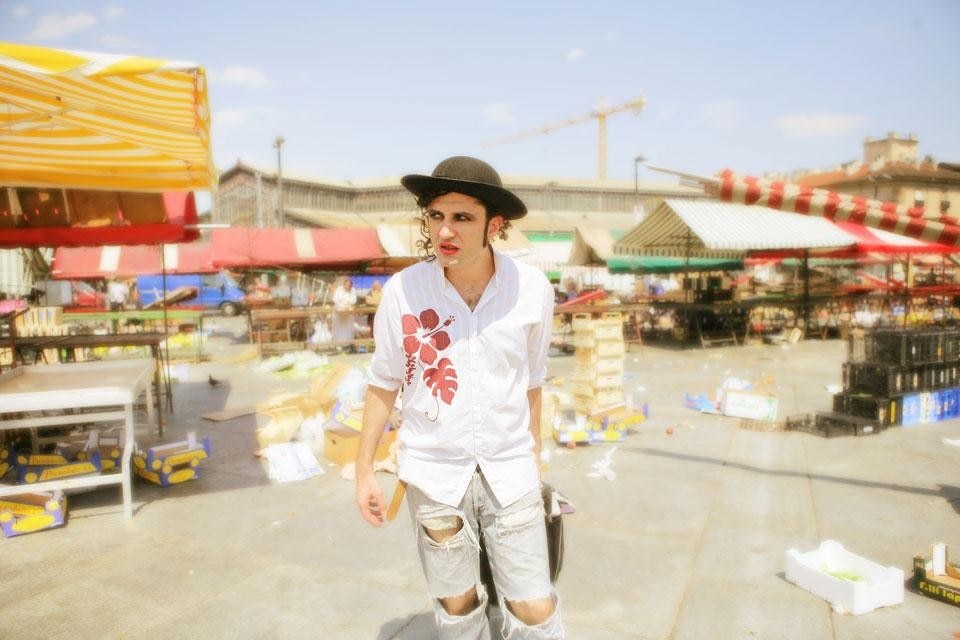
Nel caso di Irene Pittatore e Annelies Vaneycken, le artiste avevano avuto modo di conoscersi in passato e sperimentare le loro affinità durante una residenza a Rio de Janeiro. Liliya Lifanova, videoartista originaria del Kirghizistan e di base a New York, ha invece incontrato il pittore torinese Alessandro Gioiello grazie alla mediazione del curatore torinese Stefano Riba: entrambi gli artisti erano accomunati dall'utilizzo della lana nelle loro opere e dalla passione letteraria. Ancora diverso il caso di Mary Zygouri, artista performativa originaria di Atene, che aveva già maturato gran parte del progetto sul Cottolengo durante una precedente visita a Torino. Luisa Perlo delle A.titolo le ha proposto la collaborazione con Maurizio Cilli, architetto e urbanista con grande conoscenza degli archivi cittadini, il cui aiuto è stato indispensabile a permetterle di addentrarsi in un complesso come quello dell'istituto religioso che, anche urbanisticamente, si configura come un caso di "città nella città".
La globalizzazione del formato è sicuramente il sostanziale punto debole di quasi tutte le residenze internazionali. Ciò che rende Viadellafucina un’esperienza autentica è sicuramente il fatto che sia un programma nato da artisti in favore di altri artisti.

La figura dell'artista come intellettuale solitario appartiene a un cliché romantico che ha poco a che vedere con le pratiche del Novecento, almeno a partire dalle avanguardie e dalle esperienze maturate soprattutto in Germania dagli anni Settanta in poi. Trovo, anzi, che quella dell'artista sia ormai una delle figure che più si proponga di agire profondamente all'interno del tessuto civile. Con l'avvio delle pratiche partecipative negli ultimi decenni, poi, l'attitudine sociale dell'artista si è evoluta al punto da renderlo vero e proprio attivatore di processi. Sia che il lavoro abbia come effetto la pura presa di coscienza di alcuni fenomeni controversi della società contemporanea sia che si ponga come obiettivo una ricaduta concreta sul territorio, coinvolgendo la comunità di riferimento, il potenziale nelle dinamiche sociali di condivisione e nei processi di risoluzione dei conflitti dell'arte è sempre alto.

Senz'altro il momento storico che stiamo attraversando scuote dalle fondamenta anche le dinamiche produttive del sistema dell'arte. L'esplosione delle residenze in tutto il mondo dà già un primo segnale della necessità di supportare una categoria di professionisti, quale quella degli artisti, che opera in un contesto ormai internazionale e di alte competenze intellettuali, che richiedono di essere continuamente aggiornate attraverso il confronto e lo scambio. Di dono e sostegno reciproco parla anche, in maniera molto poetica, uno dei progetti in mostra, ma noi ovviamente ci auguriamo che la creatività non sia solo frutto di un generoso dono da parte dell'artista, ma che vengano individuate anche delle corrette politiche culturali, in modo da valorizzarne la funzione sociale, sostenendo maggiormente la produzione e la continuità dei progetti che dimostrano di apportare concreti benefici al contesto di riferimento.

La residenza promossa dalla Künstlerhaus Bethanien a Berlino è senz'altro un modello di riferimento per la serietà dei criteri selettivi, il supporto offerto dall'istituzione nella produzione di progetti sempre molto impegnativi e l'attitudine interdisciplinare che favorisce il dialogo tra creativi di campi diversi. Non è da sottovalutare neppure l'ottimo network di centri e gallerie per l'arte contemporanea, di artisti e curatori internazionali in città, che offre una vitalissima piattaforma per lo sviluppo creativo delle pratiche dei residenti. Un altro programma molto ambito in Europa è quello della Rijksakademie di Amsterdam, che offre spazi e borse di studio per uno o due anni agli artisti selezionati, con tutto il supporto del suo staff nella realizzazione delle ricerche. L'aspetto più interessante è che la realizzazione finale non consiste necessariamente in un lavoro finito, ma piuttosto focalizza l'attenzione sulle sue premesse teoriche, lasciando ampio spazio alla sperimentazione. Infine, guardando oltreoceano, l'International Studio & Curatorial Program (ISCP) di New York è riconosciuto come un altro importante trampolino di lancio per talenti emergenti, data la rete d'istituzioni che collaborano attivamente al programma nella grande mela, offrendo spazi e collaborazione. Quello che credo sia importante sottolineare come tratto comune a tutti e tre è la durata prolungata, per cui è possibile avere un anno a disposizione per riflettere in maniera serena e proficua sui risultati della propria ricerca. Viadellafucina, pur non disponendo ancora delle risorse adatte a sostenere un tale programma, cercherà di lavorare in modo da offrire in futuro un lasso di tempo più ampio rispetto ai due mesi previsti in questa prima edizione per l'elaborazione dei progetti.

Hanno stabilito spontaneamente una dialettica tra loro. Al primo piano della mostra allestita al K-Hole, il nostro spazio espositivo, Irene Pittatore e Annelies Vaneicken si sono interrogate, attraverso un'opera meta-testuale, sul ruolo dell'artista nei cosiddetti processi di "riqualificazione urbana" allestendo un tavolo di discussione en plein air, nel pieno centro del mercato di Porta Palazzo, con l'intento di restituire alla piazza il ruolo di centro del dibattito culturale, come nell'antica agorà. Al primo piano, Alessandro Gioiello e Liliya Lifanova presentano un cortometraggio di venti minuti, realizzato con attori non professionisti ingaggiati nel nostro quartiere, proiettando Il canto della giustizia di Rainer Maria Rilke sullo scenario urbano di Torino e Porta Palazzo. Nei sotterranei del K-Hole incontriamo invece il lavoro di Mary Zygouri e Maurizio Cilli, che si addentrano nel Cottolengo utilizzando il complesso religioso come pretesto per un'indagine sul significato del dono in un contesto di crisi economica internazionale. Se Annelies e Irene pongono una domanda sul ruolo dell'artista nella comunità e sulla possibilità per l'arte di entrarne in relazione generando mutamento, Alessandro e Liliya sembrano rispondere inglobando la comunità all'interno dell'opera, mentre Mary e Maurizio portano infine l'opera all'interno di una contesto urbano circoscritto, a partire dal lavoro concreto sul campo come volontari.

Il lavoro di Alessandro e Liliya ha portato alla produzione di un'opera chiusa, quale può essere considerato un cortometraggio: in questo caso gli artisti sono intenzionati a continuare il lavoro sull'editing per poi presentare il video con il nostro supporto all'interno di vari festival internazionali. Mary e Maurizio sono interessati a individuare nuove modalità per continuare il rapporto e l'indagine sulla struttura del Cottolengo. Infine, il lavoro di Irene e Annelies, ironizzando su un genere letterario ormai largamente in voga, porterà alla produzione di un manuale per l'artista contemporaneo: "How to move your artwork from museum to public space".